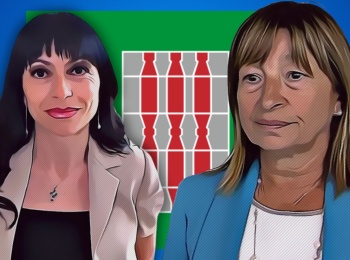Mi chiamo Lauro. Achille Lauro. Sono arrivato ottavo ma il Festival l’ho vinto io e vi ho fregato a tutti. Sì, ha vinto lui perché mai negazione artistica era arrivata a convincere tutti o quasi del contrario. Ha vinto Achille, perché aveva una canzone che era la stessa dell’anno scorso, solo con le parole cambiate, “oddio, ullallà” e “la panna montata al veleno”, quanto di più sanremese, roba che in confronto “aprite le finestre al nuovo sole” assume sfumature dirompenti. Perché è riuscito a far parlare non della miseria che cantava ma dei costumi che l’ammantavano. Perché quei costumi saccheggiavano un’epopea intera, quella del glam, da autentico robivecchi del look applicato al rock. Perché ha saputo confidare nella totale amnesia, inconsapevole o più spesso complice, di chi non sospetta la fellatio di David Bowie alla chitarra di Mick Ronson (puntualmente riciclata dal Lauro); le pomiciate en plen air del Renato Zero doc (idem); la slinguazzata di Mick Jagger sulle labbra drogate di Ron Wood al Saturday Night Live di John Belushi (come sopra); non pervenuto, invece, l’uccello offerto al pubblico da Jim Morrison, da Iggy Pop che usava flagellarsi sul palco, i brandelli di carne tenuti insieme dal nastro adesivo: o come il folle, malato, prematuramente dipartito GG Allin che i concerti li concludeva lui pure in maschera, ma di sangue, dopo aver praticato ogni genere di nefandezze sul suo corpo e anche su quello dei fan. Insomma, potremmo andare avanti un’enciclopedia: quella del rock, dove davvero le “provocazioni” di un Achille sono roba da asilo Mariuccia, neppur pallidamente originali. Perché, come avrebbe ringhiato Keith Richards, “è tutta posa, una cazzo di posa, non ha niente a che vedere con la musica e lui lo sa” (alludeva appunto a Bowie).
Certo che lo sa. Achille è il soldatino obbediente e paraculo di un Festival che, more solito, doveva spingere, fino al punto di rottura di balle, su due precise tematiche: il gender e il migrantismo, e difatti hanno mandato primo l’amico delle ong, questo Diodato che pare uno spaventapasseri con su una giacchetta, anche lui con un giulebboso pippone festivaliera. E ottavo, ma trionfatore, il nostro Achille che si è adeguato mandando precisi messaggi, di nessun senso ma che di questi tempi tirano una carriera: “io sono quel che mi sento di essere, io ho abolito i codici, l’arte (sic!) non conosce sesso”, ed altre cazzate monumentali.
In questo modo ha preso per i fondelli tutti, ma proprio tutti: prima ha accalappiato i sovranisti, che gli attribuivano, equivocando, una consonanza d’amorosi sensi in nome del nome d’arte, di certi slogan duceschi (“Me ne frego”), di chissà quali leggende metropolitane; poi, spiazzati questi dal genderino liofilizzato, ha ammaliato i compagni di merende con l’aria stonata e certi farfuglianti deliri sugli sbirri che chiedono i documenti “per du canne perché son tutti pezzidemmerda”. Tanto per non farsi mancare niente. Perché devi essere tutto e niente per essere qualcosa; devi “unire l’alto e il basso”, secondo formula abusata e vuol dire precisamente legittimare ombre di artisti in un format penoso con la scusa dei rimandi, delle citazioni di citazioni, così possiamo vederlo anche noi intellettuali spocchiosi che possiamo trovare qualcosa per cui eccitarci.
Achille ha vinto perché dirne male non si può, si passa, irrazionalmente ma a furor di retorica, per reazionari, per involuti, qualcuno ha stabilito che “se non capisci Achille Lauro, è perché hai dei seri problemi”. Ah, tu che non lo capisci, hai i problemi. Non lui. È il solito vecchio trucco, ma funziona più che mai nell’epoca dell’identità liquida, del relativismo cosmico e comico, delle primedonne che prima bisticciano sui social poi limonano in diretta per far pace. Perché oggi, se sei “solo una cazzo di posa”, puoi durare solo così, puoi fregarli così.
Quanto durerà l’Achille Laureato in rievocazioni di rievocazioni è difficile dire ma, per il momento, ci si può accontentare: lui passa all’incasso, i 50mila della partecipazione a Sanremo, i proventi immediati della canzoncina, “oddio, ullallà”, i concerti che magicamente si allungano. Solo che a riscuotere non ci va come Regina Elisabetta, ci va, anagraficamente, quale Lauro De Marinis, nato a Verona, cresciuto, in qualche modo, a Roma, di seguito codice fiscale, sesso, residenza codice a barre, segni particolari: ullallà. Sa che, se no, gli succede come a Spider Man, che quando andava a staccare l’assegno non lo pagavano perché l’impresario non si fidava, non poteva intestarlo “Al nostro stupefacente vicino di casa l’Uomo Ragno”, voleva sapere chi e cosa fosse sotto il costume, sotto la maschera da tribolato supereroe.
Max Del Papa, 11 febbraio 2020