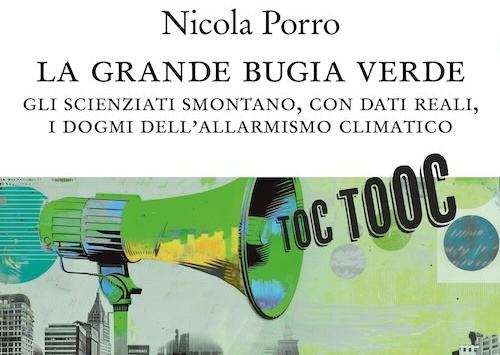Le guerre commerciali vengono generalmente descritte come un azzardo economico. Tuttavia, le crisi globali recenti hanno mostrato che il commercio internazionale ha vissuto in uno stato di torpore dentro un sistema truccato da decenni. Il presidente Donald Trump, deciso a sfidare l’ortodossia economica globalista, ha dunque scelto i dazi come leva per riaprire il dibattito sulla struttura del commercio globale.
A partire dagli anni ’90, la politica commerciale americana è stata improntata alla diplomazia e al compromesso. Ma l’era delle trattative educate è finita. Il 2 aprile, da lui ribattezzato “giorno della liberazione”, il presidente Trump ha annunciato un nuovo regime tariffario: un dazio generalizzato del 10 per cento su tutte le importazioni, e tariffe punitive contro Paesi selezionati – come la Cina – con aliquote fino al 50 per cento su alcune categorie di beni.
Il pacchetto include anche tempi di attuazione accelerati, rafforzamento dei controlli doganali per impedire triangolazioni, e una riscrittura delle regole sull’origine dei prodotti per chiudere scappatoie ormai sistematiche. È una svolta netta: per la Casa Bianca, le priorità strategiche superano il consenso multilaterale.
Un messaggio geopolitico
Questo piano non è solo una nuova politica commerciale: è un messaggio geopolitico. Gli Stati Uniti non tollereranno più relazioni economiche in cui la sistematicità dello svantaggio sia diventata la norma. Per anni, le amministrazioni americane hanno firmato accordi multilaterali in nome dell’efficienza, ottenendo in cambio solo erosione industriale.
I nuovi dazi, applicati a più di sessanta Paesi, servono a proteggere le industrie Usa da pratiche che l’amministrazione definisce “croniche violazioni delle regole del WTO”. Al centro resta la Cina, ma l’azione è globale: acciaio, elettronica, farmaceutica e componentistica auto sono tutti colpiti.
A ciò si affiancano incentivi agli investimenti manifatturieri interni, revisioni rapide delle catene di approvvigionamento strategiche, e restrizioni per le aziende che delocalizzano ma continuano a beneficiare di contratti pubblici federali. Il pacchetto disegna una politica assertiva, coerente, che mira a restituire allo Stato americano potere contrattuale, dopo anni di diplomazia diluita sotto le mentite spoglie del libero scambio.
Distorsioni deliberate e sistematiche
I settori dell’ortodossia economica protestano. L’Ocse prevede una crescita americana più lenta nel 2025, al 2,2 per cento, con un’inflazione stimata al 2,8 per cento. Le imprese segnalano pressioni sui costi. Gli analisti finanziari parlano di nervosismo tra gli investitori. I rivenditori temono il calo dei margini. Gli agricoltori paventano ritorsioni contro soia, mais e carne. Le industrie che dipendono da componenti esteri denunciano volatilità dei prezzi e interruzioni logistiche.
Secondo la teoria economica globalista, i dazi distorcono i mercati, riducono la scelta per i consumatori e provocano ritorsioni. Ma il modello globalista si fonda sulle tre ipotesi di rispetto reciproco, istituzioni multilaterali solide e commercio regolamentato. Queste ipotesi non reggono più. Il sistema attuale è stato compromesso da manipolazioni sistematiche, soprattutto da parte di regimi autoritari (Cina) e dall’approccio mercantilista (Germania).
L’obiettivo del POTUS non è ostacolare il commercio in sé, ma contrastare le distorsioni che oggi lo definiscono. La Cina ha svalutato deliberatamente lo yuan, ha sovvenzionato le proprie esportazioni, e ha protetto il proprio mercato interno. La Banca centrale cinese ha usato controlli sui capitali e interventi nei mercati valutari per garantire ai propri esportatori un vantaggio sleale. E il regime comunista tollera – se non incoraggia – il furto di proprietà intellettuale su scala industriale.
Le aziende occidentali, americane ed europee, subiscono intrusioni informatiche, obblighi di trasferimento tecnologico e discriminazioni normative. Molte imprese europee hanno già iniziato a ridurre le attività di ricerca e sviluppo in Cina. In questo contesto, i dazi non sono punizioni: sono correttivi.
Il problema delle barriere non tariffarie
Oltre alle manipolazioni valutarie e al furto di proprietà intellettuale, il commercio globale è falsato da barriere non tariffarie. La Cina impone regimi di licenza opachi, acquisti pubblici distorti e sussidi camuffati da politiche ambientali. Altri Paesi limitano i prodotti americani con barriere regolatorie: gli standard agricoli indiani, i ritardi brasiliani nella registrazione dei farmaci, i certificati giapponesi per l’automotive.
L’Unione europea, da sempre paladina del libero scambio, opera dietro un muro regolatorio fatto di esclusioni e preferenze mirate. Gli obblighi di conformità tecnica e gli standard di eco-design europei funzionano spesso come tariffe mascherate. “Fortezza Europa” predica la concorrenza, ma disegna il commercio su misura per i propri interessi. È in questo quadro che si inserisce la strategia del presidente Trump.
Il problema Usa non sono i saldi bilaterali. Gli squilibri sono strutturali e i dazi servono a fronteggiarli. Dove la diplomazia ha prodotto vaghe promesse, i dazi impongono costi reali. Funzionano come leva: rendono costosa la violazione delle regole. Non si tratta di protezionismo fine a sé stesso, ma di esercizio mirato del potere economico.
L’argomento secondo cui i dazi penalizzano i consumatori è parziale. In alcuni casi è vero, ma ignora i costi più profondi della deindustrializzazione. Qual è il prezzo della dipendenza da forniture estere per beni critici come i farmaci o i semiconduttori? L’ossessione per il costo minimo ha eroso la resilienza economica. In quest’ottica, un lieve rincaro rappresenta un investimento ragionevole nell’autonomia strategica.
Reciprocità e sovranità
C’è una differenza sostanziale tra libero scambio e scambio equo. Il primo presume condizioni di parità. Il secondo richiede regole applicabili e trattamenti equi. I critici di Trump si illudono che gli Usa trarranno vantaggio economico e geopolitico dalla retorica dell’internazionalismo liberale. Ma l’amministrazione vede il commercio come arena competitiva, non come terreno per il consenso multilaterale. I dazi, da questa prospettiva, non sono un’eccezione, ma una necessità.
L’argomentazione morale si lega a quella strategica. I lavoratori americani hanno pagato il prezzo dell’integrazione globale senza compensazioni. Le comunità industriali sono state smantellate, sostituite da impieghi precari nei servizi e dipendenza dallo Stato. Le promesse di riqualificazione si sono rivelate parole vuote. Al contrario, l’attuale politica valorizza la capacità produttiva e l’interesse nazionale rispetto all’efficienza teorica, mirando a invertire decenni di declino.
Quella del presidente Trump non è un’operazione nostalgia. È consapevolezza che un’economia ha bisogno di fondamenta: settori che costruiscono, innovano e generano valore concreto. L’ossessione per i costi minimi ha indebolito quelle fondamenta. La politica di Trump riafferma la necessità di un equilibrio. Non è una crociata contro la globalizzazione, ma un’esigenza di reciprocità e rispetto per la sovranità.
Le inefficienze esisteranno. Ci saranno costi. Non tutti i settori ne trarranno vantaggio. Ma accettare passivamente l’erosione delle capacità strategiche comporta rischi maggiori. A lungo termine, il declino mina l’indipendenza economica e la legittimità democratica. Ignorare questo dato è irresponsabile.
Gli oppositori citano spesso Adam Smith, dimenticando il suo avvertimento contro l’identificazione della politica nazionale con gli interessi del capitale transnazionale. Molte multinazionali ormai sfuggono a qualsiasi responsabilità territoriale. I dazi ripristinano l’idea che l’accesso al mercato americano non sia un diritto, ma una concessione subordinata a condizioni.
Le guerre commerciali sono complesse e rischiose. Ma quando gli obiettivi strategici vengono ignorati troppo a lungo, lo scontro diventa inevitabile. Le scelte del presidente Trump riflettono la volontà di non subire il conflitto.