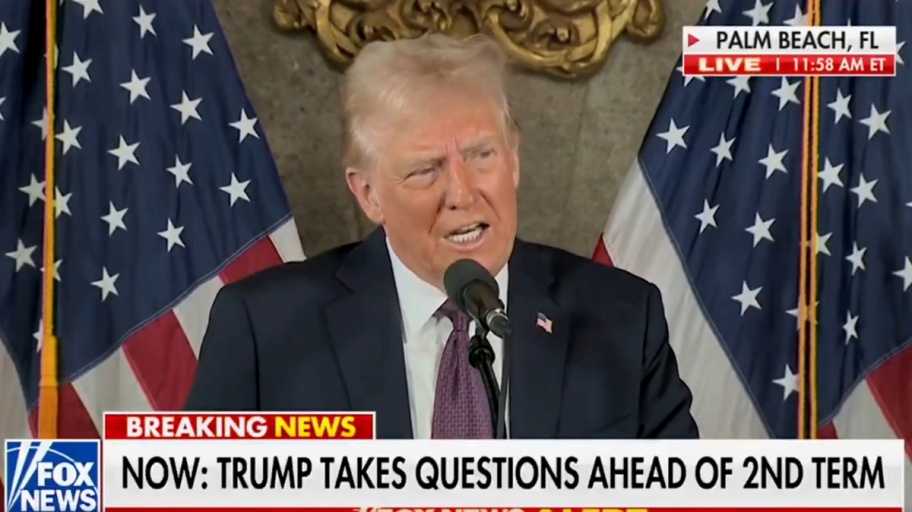La prima presidenza Trump non ha evidentemente insegnato nulla. Come allora le uscite di Donald Trump venivano liquidate come provocazioni, se non apertamente derise come le farneticazioni di un pazzo, tranne poi, a distanza di mesi o anni, dimostrarsi tutt’altro che assurde – ricorderete il duro atto d’accusa alla Germania di essere dipendente dalla Russia per il gas – così oggi le recenti dichiarazioni del presidente eletto, in particolare quelle su Panama, Groenlandia e Canada, vengono accolte qui in Europa con incredulità mista a sarcasmo, denotando una visione miope e velleitaria.
I veri pazzi, nel senso di sprovveduti che non si avvedono nemmeno del mondo in cui vivono, sono al di qua dell’Oceano Atlantico, non a Washington.
Egemonia a rischio
La tenuta dell’ordine internazionale basato sull’egemonia degli Stati Uniti è a rischio e la leadership globale Usa viene sempre più apertamente sfidata dalla Cina, ma anche da altri attori revisionisti, quali Russia, Iran e – ormai occorre inserirla – Turchia. Non scopriamo certo nulla di nuovo, è un processo in corso da almeno un quindicennio, dalla crisi del 2008, dunque da ben prima dell’arrivo del ciclone Trump.
Difficilmente troverete qualcuno che non condivida quella che ormai è diventata una ovvietà, la premessa di ogni analisi, ma sembra che molti o non ci credano veramente, o non si rendano conto delle sue implicazioni concrete. È talmente inflazionata da rischiare di svuotarsi di significato ed essere ripetuta come vuota retorica.
Se poi consideriamo che i quattro anni di presidenza Biden (e gli otto di Obama) hanno ulteriormente indebolito la posizione Usa – su questo il consenso è molto più ristretto, ma ciò che conta è che ne sia convinto chi oggi è al potere a Washington – non può sorprendere l’urgenza di rimettere le cose al loro posto, riparare i danni, restaurare e preservare la supremazia americana.
L’approccio negoziale
Né deve sorprendere l’assertività di Trump, arrivato a non escludere l’uso della forza economica e militare (anche se i media, maliziosamente, nel riportare il suo pensiero hanno citato solo la seconda). Bisogna ricordare infatti che predilige giocare d’anticipo e all’attacco, il suo approccio negoziale da imprenditore immobiliare è di mettere l’interlocutore, che sia un alleato o un avversario, sulla difensiva, aprire più partite, apparentemente non collegate tra di loro, per disorientare e misurare le sue reazioni.
Non intendiamo qui sostenere che Trump faccia o dica sempre la cosa giusta, o che i suoi piani riescano sempre, ma che bisogna tenere presente come si muove e non commettere l’errore di sottovalutarlo o pensare che le sue siano sparate a casaccio.
Prima il cortile di casa
America First significa l’interesse degli Stati Uniti prima di tutto. La visione di Trump è tutt’altro che isolazionista, come superficialmente viene ripetuto ormai da una decina d’anni. È nazionalista, il suo approccio in politica estera affonda le proprie radici nella corrente jacksoniana.
Qualcuno, per decifrare le prime uscite del presidente eletto, ha tirato in ballo, non a sproposito, la Dottrina Monroe – o una sua versione chiaramente aggiornata ai tempi attuali. Prima di tutto, Trump si preoccupa del continente nordamericano, guarda ai due confini terrestri e ai due oceani che circondano gli Stati Uniti.
Inquadrato il contesto, vediamo cosa c’è dietro le sue parole su Panama, Groenlandia, Canada e Messico e si vedrà che quelle di Trump non sono affatto pretese assurde.
Innanzitutto, dividiamo i Paesi chiamati in causa in due coppie. Canada e Messico sono due dossier essenzialmente commerciali (ovviamente nel secondo non è secondario il tema del confine, il flusso di migranti e di droga), mentre Panama e Groenlandia riguardano in senso più stretto la sicurezza nazionale.
La risposta di Washington alla sfida cinese inizia dal cortile, o meglio dai cortili di casa. Se l’America non è credibile nel respingere la penetrazione cinese in casa sua o nel vicinato, non può esserlo nemmeno nella difesa dei suoi interessi “abroad”, lontano da casa, come a Taiwan e nell’Indo-pacifico, ma anche in Europa e Medio Oriente.
Il Canale di Panama
Il messaggio a Pechino è chiaro: abbiamo visto cosa state facendo a Panama, in Messico e in Groenlandia e deve finire, con le buone o con le cattive.
Da qui la minaccia di riprendere il controllo del Canale di Panama. Costruito agli inizi del ‘900 dal genio militare Usa e controllato da Washington fino alla fine degli anni ’70, è una rotta commerciale strategica per la sicurezza economica statunitense. Qualsiasi influenza cinese nella gestione del Canale è inaccettabile e oggi i due porti di ingresso sono gestiti da una società con sede a Hong Kong, in violazione dei trattati Usa-Panama.
La questione qui è serissima e Trump ha ragione quando dice “abbiamo ceduto il Canale a Panama, non alla Cina”. Se le autorità panamensi non sono in grado di estromettere i cinesi, non resta che l’opzione di riprendere il controllo del Canale con la forza.
La Groenlandia
In Groenlandia il tema è duplice: (1) la crescente penetrazione cinese in un territorio sconfinato, ricchissimo di materie prime strategiche per la competizione economica e tecnologica del XXI secolo; (2) il controllo delle rotte marittime, la porta d’accesso all’Oceano Atlantico e al corridoio che porta davanti alle coste Usa (fondamentale via di comunicazione tra Stati Uniti ed Europa).
Un lungo tratto di mare tra la Groenlandia e il Regno Unito che deve essere monitorato e, nel caso, interdetto alla flotta russa e, un giorno forse non lontanissimo, a quella cinese. Una delle cose di cui Trump si è lamentato esplicitamente è che la zona è “piena di navi russe e cinesi”. Quindi l’enorme isola è strategica sia per le materie prime che per la posizione geografica.
Anche qui le domande da porsi sono piuttosto semplici: il Regno di Danimarca è in grado di respingere la penetrazione cinese? A giudicare dagli ultimi anni, sembra di no. La Royal Navy, la marina britannica, decisamente depotenziata dalla fine della Guerra Fredda, sarebbe in grado di impedire l’accesso alle flotte russa e cinese? Anche in questo caso la risposta sembra essere negativa.
Il tema dell’acquisizione della Groenlandia è ricorrente, non una invenzione di Trump, che vi accennò già nel 2020. Una prima proposta di acquisto fu avanzata addirittura nel 1946.
Nel 2008, la Groenlandia ha votato a favore del Self-Government Act, che ha conferito alle autorità dell’isola una maggiore autonomia, inclusa la possibilità “di negoziare e concludere accordi internazionali”, sebbene non in materia di difesa e sicurezza. Tuttavia, l’autonomia offre ampio margine per concludere accordi con stati stranieri, inclusa la Cina, per esempio in ambito minerario e portuale. E in effetti pochi anni dopo è iniziata la penetrazione cinese, con la firma di accordi e memorandum.
Ora, sebbene il ricorso alla forza sia l’ultima opzione (a Panama non sarebbe la prima volta), e in Groenlandia è già attivo un movimento indipendentista, ancora una volta i temi posti da Trump sono reali e i suoi toni ultimativi giustificati dall’urgenza imposta dalla fase storica e dallo stato di negazione in cui indugiano gli interlocutori.
Gli europei sonnambuli
Ha ragione oggi sui rischi della penetrazione cinese a Panama e in Groenlandia, così come la aveva – inascoltato – nel 2017 sulla dipendenza della Germania dalla Russia. L’importanza strategica della Groenlandia sembra essere riconosciuta da tutte le grandi potenze, americani, cinesi, russi, ma non dagli europei, i quali d’altra parte non avevano nemmeno riconosciuto il pericolo della dipendenza dal gas russo.
Nonostante si mostrino in allarme permanente e sempre più preoccupati da un possibile disimpegno Usa, sembrano ancora coltivare l’illusione di un mondo ordinato, basato sul diritto internazionale e sulla globalizzazione alla “cinese”.
Pagano ovviamente a caro prezzo gli errori di costruzione dell’Unione europea e le politiche suicide dell’ultimo decennio, l’agenda green e l’immigrazione incontrollata, che stanno provocando desertificazione industriale e destabilizzazione politica e sociale.
Le evocazioni un giorno sì e l’altro pure di formule magiche come “esercito europeo” e “autonomia strategica” servono a gratificare l’ego di qualche leader avviato verso il tramonto e a compiacere la nostalgia della grandeur perduta, ma nessuno ci crede. Non sono realistiche.