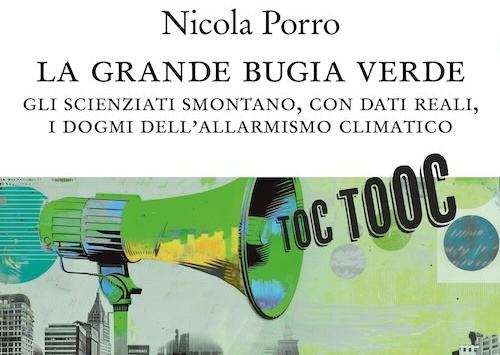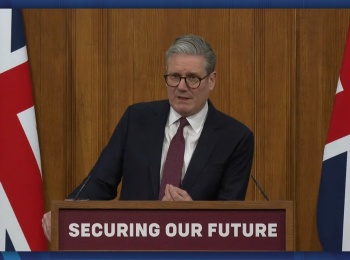È possibile, nel senso di è credibile, che nei palazzi di Bruxelles, e nelle capitali dei principali Stati europei, davvero non si abbia consapevolezza di quali siano le doglianze americane alla base della decisione dell’amministrazione Trump di aumentare a circa il 25 per cento i dazi sulle merci importate dall’Ue?
Il vittimismo Ue
Perché dalle reazioni scomposte, isteriche all’annuncio di Donald Trump e ai suoi attacchi contro l’Ue si direbbe che siano “ingiustificati”, come viene ripetuto in ogni dichiarazione e comunicato, ma nessuno parla di numeri.
No, crediamo di no. Ne sono perfettamente a conoscenza e consapevoli. Quando Trump dice “gli europei ci trattano molto male”, l’Ue è stata “creata per fregare gli Stati Uniti”, non ha tutti i torti. E il presidente americano non fa mistero di quali siano i motivi alla base di queste sue affermazioni. Siamo noi europei che cerchiamo ostinatamente di non vederli.
I nostri governi, i nostri politici – aiutati da un sistema mediatico che è ben felice di alimentare la narrazione del cattivone Trump che fa strozzinaggio nei confronti dei poveri europei, mentre è amico di Putin e Xi – tendono a nasconderli, recitano la parte delle vittime davanti all’opinione pubblica, ignara di molte delle decisioni e delle politiche antiamericane che da vent’anni vengono adottate a Bruxelles.
Avete mai provato a chiedervi se, a partire dal punto di vista commerciale fino a quello politico o militare, trattiamo gli Stati Uniti come un alleato? Forse scoprireste che lo trattiamo come alleato solo quando c’è da prendere, o da chiedere, non quando ci viene chiesto di collaborare.
Parola chiave: reciprocità
La richiesta di Trump non sembra affatto assurda: reciprocità, level playing field. Ribadisce il concetto ad ogni occasione, ieri parlando al Congresso, ma sembra che nessuno sia interessato nemmeno ad andare a verificare come stanno effettivamente le cose.
Dal 2 aprile, ha annunciato al Congresso, gli Usa applicheranno dazi corrispondenti “dollaro per dollaro” a quelli applicati da altri Paesi sui prodotti made in Usa. “Gli altri Paesi hanno utilizzato i dazi contro di noi per decenni, ora è il nostro turno di cominciare a usarli contro loro”. Ma conferma il principio della reciprocità.
Qualunque dazio ci applicheranno, noi applicheremo loro lo stesso dazio. Qualunque tassa ci applicheranno, noi applicheremo loro una tassa. Se loro applicheranno barriere non monetarie per tenerci fuori dal loro mercato, allora noi applicheremo barriere non monetarie per tenerli fuori dal nostro. Prenderemo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro come non abbiamo mai visto prima.
Ma se il principio è questo, chi applica dazi bassi nei confronti degli Usa, o è disposto ad abbassare le proprie barriere, non ha da temere, sempre che creda nel libero mercato e in una competizione fair, equa. Basterà sedersi al tavolo con Trump e delle due l’una: o dimostrargli che i suoi calcoli sono sbagliati, e quindi i suoi dazi ingiustificati, e chiarire l’equivoco; oppure concordare un livello di dazi e barriere non tariffarie reciproco, il più possibile omogeneo.
Esempio concreto, semplificando: se in media applico un dazio del 10 per cento sui prodotti Usa e Trump porta il suo al 25, allora ho il diritto di gridare all’ingiustizia. Ma se applico il 25 e lui pareggia il suo al 25, o me ne sto zitto o gli propongo di portarci entrambi al 15, o meglio al 5.
Gli strepiti di questi giorni da parte non solo dell’Ue, ma anche di Messico e Canada, nascondono evidentemente una situazione profondamente distorta di cui si vuole continuare a trarre vantaggio, ma se è così, non si vede perché Trump non dovrebbe parificarla.
I dazi autoimposti
Innanzitutto, ci lamentiamo dei dazi di Trump ma non vediamo i dazi che ci siamo autoimposti. O meglio, che l’Ue ha imposto alle imprese e ai consumatori europei. Al Parlamento europeo Mario Draghi ha citato uno studio del Fondo monetario internazionale secondo cui le barriere interne al commercio intra-Ue valgono da sole un dazio del 45 per cento sui prodotti e del 110 per cento sui servizi.
Non sappiamo se conteggiato o meno nello studio, ma in particolare sui prezzi dell’energia, cioè sul caro bolletta, vanno considerati i costi del sistema ETS, la tassa sulle emissioni di Co2, e dei sussidi alle rinnovabili.
Ogni pretesto è buono
Essenzialmente, l’Ue sfrutta opportunisticamente qualsiasi pretesto pur di alzare le sue barriere commerciali nei confronti degli Stati Uniti, in una misura probabilmente senza pari rispetto ad altri competitor globali, come per esempio la Cina.
Basti vedere la facilità con cui le auto cinesi stanno già invadendo il mercato europeo. In generale, sembra che sui prodotti provenienti dalla Cina non sussistano tutte quelle preoccupazioni di sicurezza, igienico-sanitarie, ambientali, che invece frenano o impediscono alle merci made in Usa di arrivare in Europa, nonostante sia cristallino e ammesso da tutti che i costi estremamente competitivi delle merci cinesi sia dovuto a forme di dumping e a comportamenti commerciali scorretti.
Non ci sono solo i dazi veri e propri imposti dall’Ue sui prodotti importati dagli Usa, che comunque sono multipli (tre o quattro volte) quelli imposti dagli Usa sui nostri prodotti. A pesare sono soprattutto le barriere non tariffarie, come regolamenti estremamente restrittivi che non rendono costoso, ma spesso impossibile per alcune merci Usa entrare in Europa.
La spesa militare
Non a torto, Trump considera tutto in termini commerciali. C’è il noto tema delle spese militari, il fatto che gli Stati europei abbiano eserciti “sulla carta” (e forse anche “di carta”), che non si sa se siano in grado di combattere, e sono quindi eccessivamente dipendenti dagli Usa per la loro difesa, anche convenzionale. Dato il livello di benessere che l’Europa ha raggiunto da almeno 50 anni, questa dipendenza è giustamente vista come free riding, scrocconismo.
Dopo anni di promesse non mantenute, sembra ora che gli europei si stiano muovendo, ma siamo ancora agli annunci, quelli di Starmer, Merz e Von der Leyen in questi giorni.
La scusa delle fake news
Un tema lo ha posto il vicepresidente J.D. Vance a Monaco: i valori condivisi che non sembrano più tanto condivisi. La censura, le minacce concrete alla libertà di parola in Europa a causa di normative come il DSA, con la scusa di combattere il cosiddetto hate speech e la disinformazione online, le fake news, hanno ricadute anche commerciali. Vance lo ha fatto capire:
Abbiamo un rapporto speciale con i nostri amici nel Regno Unito e anche con alcuni dei nostri alleati europei. Sappiamo anche che si sono verificate violazioni della libertà di parola che in realtà non hanno avuto ripercussioni solo sugli inglesi (ciò che gli inglesi fanno nel loro Paese è una decisione che spetta a loro), ma hanno avuto ripercussioni anche sulle aziende tecnologiche americane e, per estensione, sui cittadini americani.
La scusa del Green Deal
Anche la lotta ai cambiamenti climatici è stata usata dall’Ue come arma commerciale per proteggere la sua produzione interna dalle asimmetrie auto-inflitte. La direttiva CSRD obbliga le imprese di una certa dimensione, europee ed extra-Ue, a redigere un bilancio di sostenibilità ESG (ambientale, sociale e di governance); la direttiva CSDDD obbliga a severe due diligence in materia di sostenibilità ambientale e diritti umani; ma soprattutto il CBAM, “Carbon Border Adjustment Mechanism”, in vigore dal 2026, che in pratica applicherà un dazio per le emissioni di Co2 incorporate nei prodotti extra-Ue paragonabile al costo sostenuto dai produttori Ue nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (ETS).
Un pilastro del Green Deal: la ratio è che siccome le industrie europee vengono tassate con i certificati carbonio che sono obbligate a comprare a seconda delle loro emissioni, allora dobbiamo tassare anche quelle extra-Ue perché non soffrano uno svantaggio competitivo. Insomma, è come imporre l’ETS anche alle industrie extra-Ue. Vi sembra che questa cosa possa essere accettabile dall’amministrazione Trump?
La scusa della concorrenza
Lo strumento dell’Antitrust, anche, è stato usato per colpire le compagnie americane basandosi su una concezione delle concentrazioni monopolistiche antiquata, novecentesca. La commissaria Margrethe Vestager si è divertita per un decennio con il bazooka. Come mai d’un tratto tutte le maggiori Big Tech Usa, fino a ieri schierate con i Democratici, si sono allineate a Trump? Semplicemente saltate sul carro del vincitore? No, una delle ragioni è che Trump ha promesso loro di proteggerle dalle angherie e dal bullismo Ue, ottenendo in cambio che tornassero a investire negli Stati Uniti.
Lo stesso Trump, giovedì scorso, prima del suo incontro con Starmer, ha ricordato ai giornalisti le cause intentate contro Apple: “Ho avuto problemi con l’Ue perché ci hanno imposto dei dazi. Lo fanno sotto forma di una tassa Iva, che è circa del 20 per cento. Fanno causa alle nostre aziende, hanno fatto causa ad Apple. E cambieremo tutto questo. Avremo tariffe reciproche“. Anche le digital tax contro i “colossi del web”, contro chi credete che siano state introdotte se l’Ue non ha “colossi del web”?
Ecco cosa ha risposto al Foglio Joel Kaplan, braccio destro di Mark Zuckerberg ed ex dello staff di George W. Bush, in Italia per incontrare Giorgia Meloni, quando il direttore Cerasa gli ha chiesto dei dazi e degli attacchi di Trump all’Ue.
Nell’ultimo periodo, negli ultimi vent’anni, l’Ue abbia misurato il suo successo normativo in base all’entità e al numero di multe inflitte alle aziende tecnologiche statunitensi. E pensiamo che questo non sia stato positivo per la volontà o capacità delle aziende tecnologiche di investire in Europa, per la crescita e la competitività europea. Non sta funzionando. Vogliamo quindi impegnarci in modo costruttivo con i politici europei per trovare una direzione migliore e più produttiva, ma certamente la nostra esperienza è che ci sono stati diversi casi in cui l’Europa ha preso di mira le aziende tecnologiche statunitensi con tasse discriminatorie e ingiuste, o con l’applicazione di normative o multe, che insieme si sommano a barriere non tariffarie piuttosto significative per le aziende Usa.
Se questo dovesse continuare, ha avvertito, i rapporti con l’amministrazione Trump, già tesi, si inasprirebbero ulteriormente:
Credo sia sufficiente capire che il presidente Trump sosterrà senza mezzi termini le aziende e gli interessi degli Stati Uniti e che risponderà male quando riterrà che siano state trattate ingiustamente o in modo discriminatorio.
La “buona notizia” è, fa notare Kaplan, che tutto quello che chiede è un contesto normativo non punitivo, equo con le aziende Usa, favorevole alla crescita e all’innovazione e questo farà bene anche all’Europa. Peccato che non abbiamo politici e burocrati in grado di rendersene conto. La situazione è questa: l’America innova, la Cina copia e l’Europa tassa e regolamenta.
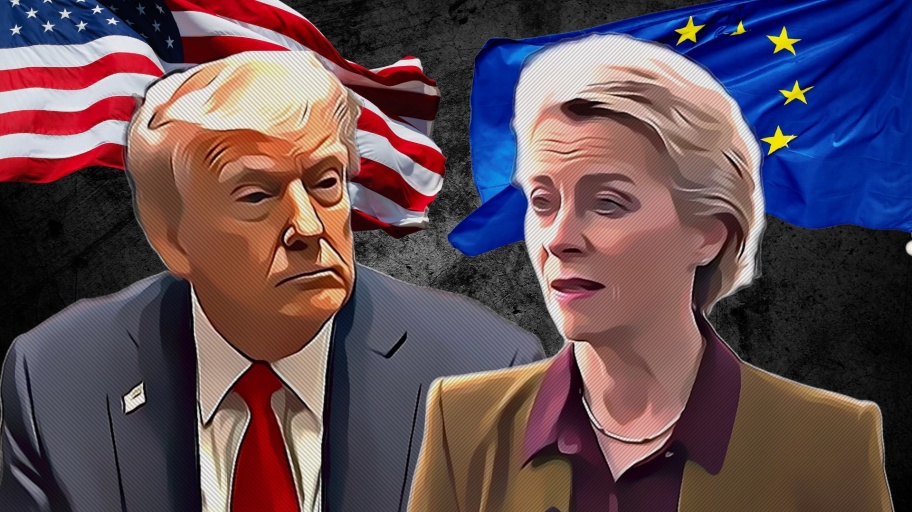 © STILLFX, P_Wei e forgiss tramite Canva.com
© STILLFX, P_Wei e forgiss tramite Canva.com