“Truccate: come i media, Big Tech e i Democratici hanno sequestrato le nostre elezioni”. Così suona in italiano il titolo del nuovo libro di Mollie Hemingway, giornalista-scrittrice, commentatrice politica, senior editor del prestigioso online magazine The Federalist, nonché collaboratrice di Fox News. Il New York Post ne ha offerto in esclusiva un estratto che definire imperdibile è il minimo. A nostra volta ne facciamo una sintesi ad uso del pubblico italiano, cercando di rendere giustizia agli aspetti essenziali dell’opera.
Diciamo preliminarmente che Mollie Hemingway padroneggia egregiamente la difficile arte del giornalismo rigoroso e riflessivo di vecchia scuola, e se ne avvale per documentare l’assalto perpetrato nel 2020 contro l’America ad opera della sciagurata alleanza tra il movimento progressista, la burocrazia, i news media e il Big Tech.
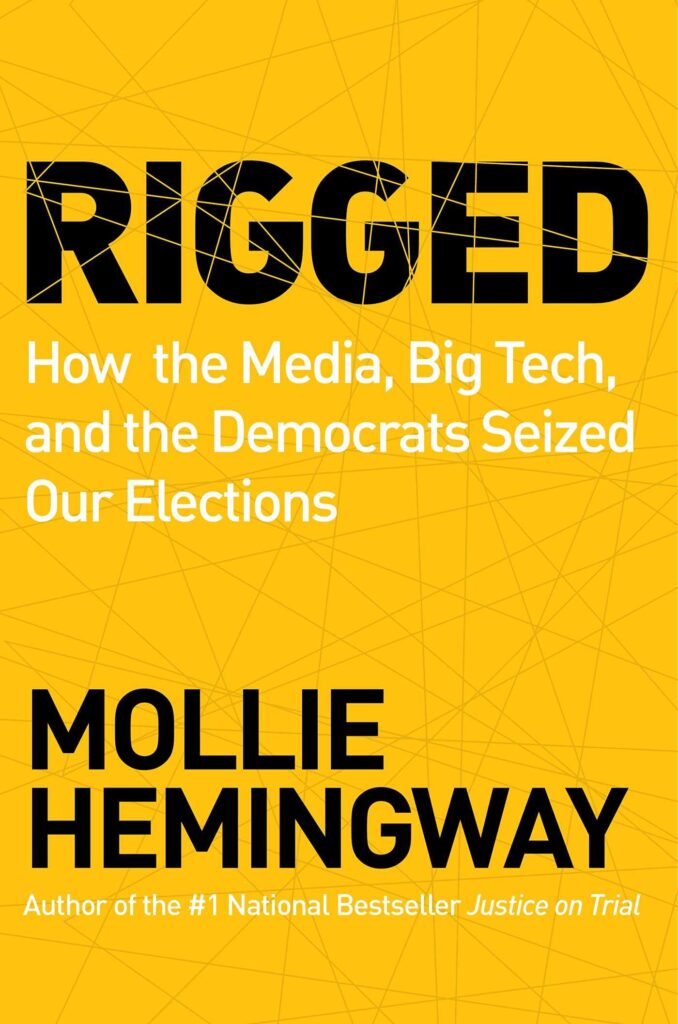
La vittoria di Trump nel 2016, spiega l’autrice, è stata uno shock per una parte non trascurabile degli Stati Uniti, ma la Silicon Valley l’ha presa particolarmente male, tanto che i signori della tecnologia hanno cominciato a contrattaccare. In un incontro, il fondatore di Google Sergey Brin ha suggerito che “Jigsaw”, un progetto sviluppato dal più grande motore di ricerca per combattere la propaganda terroristica islamica, poteva essere utilizzato per plasmare le opinioni degli elettori di Trump. Dopo l’insediamento di quest’ultimo, un ex ingegnere di Google aveva detto al giornalista di Breitbart Allum Bokhari che gli attivisti all’interno dell’azienda avevano formato un gruppo di lavoro per raccogliere idee su come utilizzare le risorse di Google per minare l’amministrazione Trump. Un’altra testa d’uovo di Google voleva sabotare il telefono di Trump, che funzionava sul sistema operativo Android di Google, oltre a vietare gli account Gmail degli alti funzionari dell’amministrazione Trump. Come se non bastasse, un dipendente del dipartimento pubblicitario di Google ha pensato bene di indirizzare personalmente gli acquirenti di annunci Google al sito web di Sleeping Giants, un gruppo di attivisti che incoraggia il boicottaggio delle agenzie di stampa conservatrici.
Coi social media non è andata diversamente. Alcuni dipendenti di Facebook – non ridete per favore – si sono letteralmente presi una settimana di ferie per elaborare il lutto. BuzzFeed ha riferito che “i dipendenti di Facebook hanno formato una task force non ufficiale per mettere in discussione il ruolo svolto dalla loro azienda nella promozione di notizie false che hanno favorito la vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi della scorsa settimana”.
Nel dicembre 2016, Zuckerberg cedette alle pressioni interne, e Facebook adottò una nuova politica per cercare di combattere le presunte fake news che hanno turbato le notti e i sogni dei dipendenti di sinistra del gigante di Menlo Park, California. Facebook, insomma, cominciò a pagare dei media outlets per “verificare i fatti” delle notizie riportate sul sito. Con le entrate di molte testate giornalistiche in costante calo – in gran parte perché Facebook aveva radicalmente sconvolto i tradizionali modelli di business giornalistici – quelle che un tempo erano rispettabili organizzazioni giornalistiche si sono precipitate a partecipare al programma di fact-checking.
Diciamolo, comunque: che le aziende Big Tech lo ammettano o meno, la rabbia della Silicon Valley per la vittoria di Trump riguardava principalmente la loro incapacità di controllare l’opinione pubblica americana. Dopotutto, nelle due precedenti elezioni, l’industria tecnologica si era vantata pubblicamente di aver aiutato le due campagne vittoriose di Obama. Si noti che, per anni, quei signori hanno esaltato oltre misura il favoloso potenziale di Internet, cioè la concreta possibilità di diventare un’oasi libertaria digitale in grado di offrire alle persone un modo per liberarsi dalle istituzioni che storicamente hanno cercato di controllare ciò che la gente pensa e fa. E quando, nel 2012, il general manager di Twitter nel Regno Unito, Tony Wang, definì quel social media, quella piattaforma, come “l’ala della libertà di parola del partito per la libertà di parola”, al di qua e al di là dell’oceano scrosciarono gli applausi: ci credevamo, ci credevamo in tanti. Purtroppo la reazione orwelliana della Silicon Valley al 2016 ha dimostrato una volta per tutte che i visionari delle aziende tecnologiche americane erano oppressori, non liberatori.
Un paio di esempi illuminanti:
1) nel 2018, una gola profonda di Google ha fatto trapelare un documento eloquentemente intitolato “The Good Censor” e ha riassunto il ruolo di Google nel “mediare” il dibattito politico americano in questo modo: “La libertà di parola è diventata un’arma sociale, economica e politica”;
2) nel gennaio 2018, Project Veritas, una testata giornalistica specializzata in indagini sotto copertura, ha pubblicato il video di un ex “agente di revisione dei contenuti” su Twitter. L’agente ha ammesso che la piattaforma era prevenuta contro i conservatori, mentre i dipendenti di Twitter che esaminano contenuti discutibili “lasciano passare molte delle cose di sinistra o liberal senza controllo”.
L’indagine di Veritas ha visto anche la presenza di un ex ingegnere informatico di Twitter che ha ammesso che la società ha “bandito” gli utenti, un termine per indicare quando le società di social media utilizzano determinati algoritmi per ridurre la visibilità di taluni utenti, naturalmente senza dirglielo.
Numerosi conservatori di spicco avevano visto improvvise diminuzioni del coinvolgimento sui social media e sospettavano da tempo che ciò stesse accadendo. Nel gennaio 2020, Twitter ha aggiornato i suoi termini di servizio per affermare formalmente il diritto di “limitare la distribuzione o la visibilità di qualsiasi contenuto sul servizio”. Più chiaro di così…
E pensare che nel dicembre 2018, il ceo di Google Sundar Pichai testimoniò sotto giuramento davanti al Congresso degli Stati Uniti che la società non “interviene manualmente” nei risultati del motore di ricerca. Salvo poi venire a scoprire che YouTube, di proprietà di Google, e il secondo motore di ricerca più popolare al mondo dopo lo stesso Google, aveva una “lista nera” – il termine è di Google – relativa a una serie di argomenti politici. Se hai cercato su YouTube notizie sull’aborto, o sulla deputata democratica Maxine Waters, o sull’attivista per il controllo delle armi David Hogg, o su altri argomenti politici, stai certo che Google ha truccato i risultati. “Abbiamo tonnellate di liste bianche e nere che esseri umani curano manualmente”, ha affermato un dipendente di Google.
Sembra inoltre che Google abbia intenzionalmente ridotto il posizionamento nei motori di ricerca e la visibilità dei media conservatori. Un rapporto di settembre 2020 in RealClearPolitics di Maxim Lott ha setacciato i dati della società di consulenza Sistrix, che tiene traccia dei dati relativi all’ottimizzazione dei motori di ricerca. I dati mostrano chiaramente che, a partire dal 2017, “i siti di notizie conservatori tra cui Breitbart, Daily Caller e Federalist hanno visto i loro elenchi di ricerca di Google ridotti drasticamente”. E Google stava rendendo assurdamente difficile trovare informazioni specifiche sui contenuti conservatori.
La decisione di bloccare i siti web conservatori è stata quasi certamente intenzionale. Un dipendente ha descritto Breitbart e The Daily Caller in modo specifico come “blog di opinione” che non dovrebbero essere equiparati ai media aziendali nei risultati di ricerca, anche se entrambi i siti web svolgono un ruolo fondamentale nel campo dell’informazione.
Insomma, è innegabile che Google manipoli i risultati su argomenti politicamente sensibili e che il risultato di ciò sia politicamente svantaggioso per i conservatori.
L’effetto di questo sulle elezioni sembra essere molto più significativo di quanto non si creda. A partire dal 2012, lo psicologo Robert Epstein, ex caporedattore di Psychology Today, ha condotto una serie di esperimenti per accertare il grado in cui i risultati distorti dei motori di ricerca possono influenzare l’opinione politica. La maggior parte delle persone vede erroneamente i risultati dei motori di ricerca come il prodotto della neutralità meccanica, semplicemente il posizionamento e l’ordinamento dei risultati, e ne è facilmente influenzata. Epstein, un Ph.D. di Harvard politicamente liberal, avrebbe successivamente riferito che durante il 2016 “tutte e 10 le posizioni nella prima pagina dei risultati di ricerca [di Google] negli stati blu e negli stati rossi” erano prevenute a favore di Hillary Clinton. Sulla base delle conclusioni dei suoi precedenti esperimenti, Epstein ha stimato che solo Google potrebbe aver convinto 2,6 milioni di americani a votare per Hillary Clinton. Nel 2019, Epstein avrebbe detto alla Commissione Giustizia del Senato che la manipolazione dei motori di ricerca è “una delle forme di influenza più potenti mai scoperte nelle scienze comportamentali”.
Nel 2020, Epstein ha monitorato i risultati di Google utilizzando oltre settecento volontari in tre stati in bilico e ha concluso così:
“I risultati di ricerca di Google erano fortemente sbilanciati a favore di liberals e Democratici. Questo non succedeva su Bing o Yahoo. Il risultato è che tutte queste manipolazioni possono aver spostato almeno sei milioni di voti in una sola direzione. Abbiamo anche trovato quella che sembra essere una pistola fumante. (…) Cioè, abbiamo trovato un periodo di giorni in cui il promemoria del voto sulla home page di Google veniva inviato solo ai liberali: nessuno dei nostri agenti conservatori sul campo ha ricevuto un promemoria del voto in quei giorni”.
Con l’avvicinarsi delle elezioni del 2020, le società di social media, guidate dalla pressione interna dei dipendenti e dalla pressione esterna degli attivisti liberal, hanno iniziato a prendere di mira direttamente Trump. Per la maggior parte del resto dell’anno elettorale, Twitter bloccò regolarmente o censurò in qualche modo i tweet del presidente. La censura ha rivelato eclatanti doppi standard. In un’udienza davanti alla Knesset israeliana a luglio, a un rappresentante di Twitter è stato chiesto perché la società stesse censurando Trump ma non avesse fatto nulla contro l’ayatollah Khamenei iraniano, che aveva ripetutamente chiesto la distruzione di Israele e il genocidio ebraico. Poco più di una settimana prima del tweet censurato di Trump sui saccheggi delle rivolte seguite al barbaro assassinio di George Floyd, Khamenei aveva twittato: “L’unico rimedio fino alla rimozione del regime sionista è la ferma resistenza armata” e Twitter non ha fatto nulla. La risposta di Twitter alla Knesset è stata ipocrita, per usare un eufemismo. Khamenei ha ottenuto un pass gratuito perché “i commenti su questioni politiche del giorno, o schiamazzi di politica estera su questioni economiche o militari, generalmente non violano le nostre regole di Twitter”.
Facebook una volta ha sbandierato la sua capacità di bloccare l’80 per cento del traffico Internet a qualsiasi collegamento che sia ritenuto fuorviante. Nel decidere chi censurare, Facebook si è affidato ai “fact-checkers” dei media che si considerano il partito di opposizione. Ai giornalisti di parte è stato dato il potere di cancellare i loro rivali da Internet. In tal modo una marea di notizie utili e interessanti sono state soppresse e si è data una grossa mano a Biden affinché tagliasse il traguardo da vincitore. “In Facebook, abbiamo preso molto sul serio la nostra responsabilità di proteggere l’integrità di queste elezioni… Abbiamo costruito sistemi sofisticati per proteggerci dalle interferenze elettorali”, ha dichiarato Mark Zuckerberg a ABC News poco dopo le elezioni. I risultati sono stati sicuramente “brillanti”, almeno dal punto di vista del ceo del gigante tecnologico. Peccato che a farne le spese sia stata e sia tuttora la democrazia americana.



