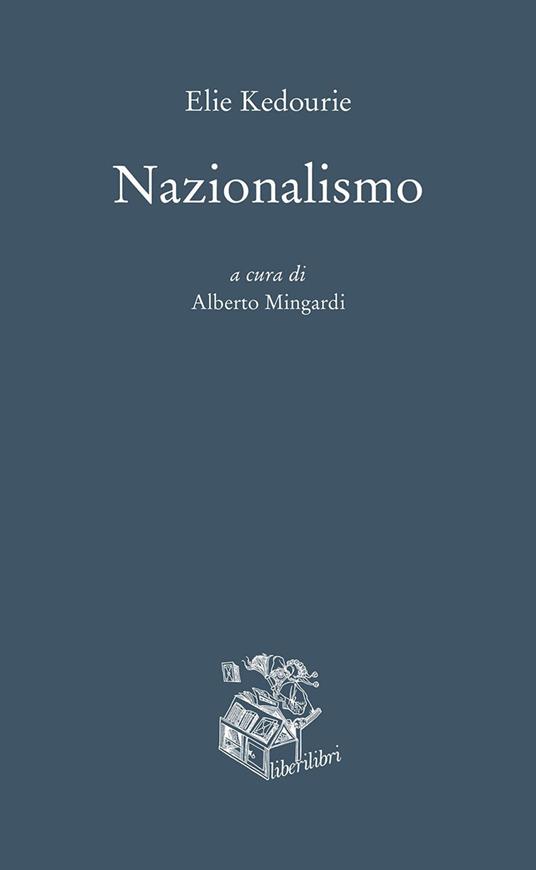In libreria si trova, fresca di stampa, la prima traduzione italiana di un piccolo classico (ancorché negletto) della scienza politica mondiale: “Nazionalismo” (edizioni Liberilibri), di Elie Kedourie, con la curatela di Alberto Mingardi, cui si deve peraltro un saggio introduttivo così ampio, brillante e informato da farne davvero un libro nel libro. Nazionalismo è particolarmente attuale in questi giorni, in cui una delle possibili chiavi di lettura del conflitto in Ucraina viene fornita proprio dal sentimento “nazionalista”, il quale può, a ben vedere, valere per descrivere sia l’atto di aggressione russa, sia quello della resistenza ucraina. Per un verso, infatti, può intendersi come “nazionalista” la volontà di potenza mostrata da Putin, il quale vorrebbe ricostruire l’unica nazione slava, richiamandosi all’entità politica nota come la Rus’ di Kiev, che includeva i territori della Russia europea, l’Ucraina e la Belarus. Per altro verso, però, “nazionalista” suona anche la reazione degli invasi: il presidente Zelensky, rivolgendo un messaggio ai cittadini russi, ha infatti fatto leva sull’autonomia del popolo ucraino, che può essere certo arricchito dal confronto culturale con i vicini, senza che “questo non li renda un tutt’uno”, dissolvendo l’uno nell’altro.
La possibilità di fare ricorso al medesimo concetto per inquadrare entrambi i fronti avversi in un conflitto suggerisce l’opportunità di una riflessione ulteriore sul significato e sul valore euristico di quel concetto. In breve: che cos’è il nazionalismo? Ha davvero senso parlare di nazionalismo in questo caso? Per affrontare la prima domanda, il libro in parola, come già anticipato, è preziosissimo. Il suo autore, Kedourie, è nato nel 1926, da genitori ebrei, a Baghdad: negli anni precedenti, la città era stata una delle “capitali” dell’Impero ottomano e la comunità ebraica conviveva con quella musulmana (a maggioranza sciita, ma con presenze importanti curde e sunnite) e quella cristiana, in una posizione di prestigio politico ed economico (il censimento del 1908 mostra che gli ebrei contavano 53 mila dei 150 mila abitanti complessivi). Alla nascita di Kedourie, però, le cose stavano cambiando, e non per il meglio. Gli inglesi, che occuparono le province ottomane nel 1917, promossero rivendicazioni “nazionaliste” da parte dei gruppi (minoritari) arabi, nella speranza che una ribellione nei confronti della Sublime porta avrebbe accorciato i tempi della Prima Guerra Mondiale. L’obiettivo tattico si concretizzò, e, come “ricompensa”, gli inglesi patrocinarono la nascita dello Stato dell’Iraq, affidandone la guida proprio a una dinastia sunnita. Quest’ultima promosse una politica pan-arabista, che individuò nella comunità ebrea uno dei bersagli principali: all’indomani della nascita di Israele, l’accusa di “sionismo” rivolta agli ebrei di Baghdad fu l’occasione per giustificare violenze, vessazioni e, infine, rendere inevitabile la loro emigrazione di massa. Il sorgere del nazionalismo arabo e della nazione irachena aveva condotto all’espulsione della comunità ebrea dal Paese che era stato “suo” per più di due millenni.
Kedourie, che conosceva l’inglese, lasciò Baghdad per Londra nel 1947, iscrivendosi alla London School of Economics, destinata a diventare la sua casa accademica per quasi quarant’anni. Lì, Kedourie si legò al filosofo politico Michael Oakeshott e al cenacolo culturale liberal-conservatore che si raccoglieva intorno a quest’ultimo e ai suoi amici/allievi (da Kenneth Minogue a Shirley e Bill Letwin). Fu proprio Oakeshott a indirizzare Kedourie allo studio del “nazionalismo”. Il risultato della sua indagine è una “demolizione” sistematica di qualsiasi aspetto positivo ricollegato alla dottrina in parola da quella retorica romantica che – scrive lo stesso Kedourie – l’ha sostanzialmente “inventata in Europa all’inizio del diciannovesimo secolo”. Chi sospettasse di un cieco pregiudizio di Kedourie nei confronti dell’oggetto del suo studio (d’altronde, annota Mingardi nel suo saggio introduttivo, dietro ogni teoria c’è una biografia), sarebbe costretto a ricredersi.
Con il rigore proprio dello studioso, infatti, Kedourie individua anzitutto le radici intellettuali del nazionalismo. Quest’ultimo andrebbe compreso alla stregua di una perversione del concetto illuministico di autodeterminazione, che Kant aveva collegato al piano individuale e che i suoi eredi (per primo Fichte) hanno invece spostato a livello dello Stato: in altre parole, l’individuo slegato dai vincoli “tradizionali” (l’ordine fondato sulla religione rivelata e il diritto naturale) ha fornito il calco sul quale è stato modellato il concetto stesso di nazione. Kedourie non vuole certo negare l’esistenza di comunità politiche antiche e dotate di una certa fisionomia “individuale”, bensì constatare come, proprio agli albori del diciannovesimo secolo, questo rilievo “descrittivo” sia invece divenuto “prescrittivo”: non solo esistono comunità coese, ma non ne possono esistere di plurali. Come l’individuo kantiano riconosce nella sola legge morale “interna” il parametro di giudizio (meglio: auto-giudizio), sicché l’autolegislazione dell’io si converte in autodeterminazione del soggetto in conformità con la sua natura più autentica, così la nazione post-kantiana trova nell’omogeneità, anch’essa “interna” (culturale, valoriale e linguistica), la via dell’autodeterminazione collettiva: essa non risponde che a quel parametro, non può che essere giudicata se non in base a quel parametro.
Un “conservatore realista” come Kedourie rileva agevolmente la tragica ironia di questo processo “evolutivo”: il concetto illuminista di autodeterminazione è passato, nel giro di qualche decennio, da strumento di emancipazione dell’individuo a mezzo di suo intruppamento nelle fila di una comunità, non più associazione volontaria di uomini liberi ma pervasa da un sentimento assolutizzante e persino misticizzante. Tutto ciò ha condotto, per un verso, a pensare la nazione non più come un “insieme di individui” ma come una entità che vive di vita propria, e, per altro verso, a ritenere che l’individuo possa realizzarsi solo all’interno di una precisa nazione. È questa “visione strettamente monodimensionale dell’identità, dove a una lingua corrisponde una cultura, a una cultura un territorio e a un territorio uno Stato” a costituire “il lascito più evidente delle dottrine nazionaliste”, ed “è paradossale che proprio quegli uomini di pensiero che volevano essere artefici a pieno titolo del proprio destino, se ne siano disegnati uno in bianco e nero”, chiosa Mingardi.
Si diceva, in apertura, della nota di attualità che Nazionalismo ha alla luce del particolare momento geopolitico. Curiosamente, essa è in parte prefigurata proprio dall’introduzione che Kedourie ha apposto alla quarta edizione del suo testo, pubblicata all’indomani della dissoluzione dell’URSS (primavera 1992). Scrive l’autore che “la scomparsa della superpotenza sovietica, che pure è stata così oppressiva per i suoi sudditi, ha creato un pericoloso squilibrio di potere fra i suoi antichi componenti e fra essi e i suoi vicini. Esiste la possibilità di conflitti seri. La Russia, che non può essere definita altro che una grande potenza in senso classico, è circondata da Stati molto più deboli che si sono separati dalla struttura sovietica. Le Nazioni Unite non hanno la forza di evitare che la Russia allunghi le mani su possedimenti che un tempo erano degli zar e poi sono diventati sovietici. I pericoli che derivano dalla balcanizzazione non sono confinati ai Balcani”. Non è certo questa la sede – ammesso che un tale luogo esista davvero – per esprimere un giudizio definitivo sulle sorti della controversa dottrina nazionalista o su quanto essa serva davvero a comprendere le logiche, drammatiche, che stanno dietro alla guerra di Putin. Ciò che è certo, però, è che Nazionalismo di Kedourie è una lettura importantissima, oggi più che mai. Lo studio della storia delle idee non conserva un interesse meramente archeologico.