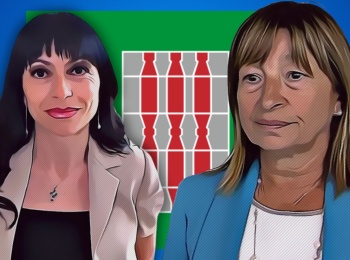La legge delega per la riforma fiscale, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contiene una novità interessante per il settore immobiliare. Fra i “principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche” (articolo 5), si prevede infatti “la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione”.
Si tratta, in sostanza, di applicare anche agli affitti non residenziali il regime sostitutivo dell’Irpef introdotto nel 2011, dal governo Berlusconi, per le “unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo”. Con aliquota del 21%, ridotta prima al 19%, poi al 15% e infine al 10% per le locazioni a canone “concordato” sulla base di accordi stipulati in sede comunale fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Rispetto al testo presentato dal governo, il Parlamento ha inserito una limitazione, prevedendo un requisito soggettivo in capo al locatario (deve trattarsi – come visto – di esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione) di cui, francamente, non si avvertiva la necessità, soprattutto trattandosi di legge delega.
Il principio introdotto è importante. L’esigenza di una tassazione proporzionale (flat, si direbbe ora) per questa tipologia di locazioni è sentita da molto tempo. E significativo è che a manifestarla siano le rappresentanze di entrambe le parti contrattuali, proprietari ed esercenti. Anche questi ultimi, infatti, si sono resi conto che l’eccesso di imposizione sui locatori danneggia gli stessi inquilini. La somma di Irpef, addizionale comunale Irpef, addizionale regionale Irpef, Imu e imposta di registro (per citare solo le voci più rilevanti) porta a un carico talmente esorbitante da produrre inevitabili conseguenze sul livello dei canoni di locazione e sulla stessa possibilità di incontro fra domanda e offerta di immobili.
Del resto, ed è ciò che molti non comprendono e molti altri fingono di non comprendere, il reddito da locazione ha delle peculiarità che non ne consentono l’assimilazione ad altre tipologie reddituali e che giustificano un trattamento tributario diverso. A incidere fortemente sono, in particolare, due elementi. Da un lato, gli oneri di manutenzione del bene, sempre più rilevanti, anche a causa di obblighi in essere o minacciati (si pensi alla proposta di direttiva “case green”). Dall’altro, i vincoli contrattuali, che nel caso delle locazioni a uso diverso dall’abitativo sono assolutamente fuori dal tempo. Basti leggere, al proposito, quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge col quale, nel 2014, si stabilì – limitatamente alle locazioni con canone annuo superiore a 250mila euro (anche se il testo originario conteneva la cifra di 150mila, poi incrementata in sede parlamentare) – di disciplinare pattiziamente i termini e le condizioni del rapporto, in deroga alla legge dell’equo canone del 1978, così “valorizzando pienamente l’autonomia privata”, diceva la stessa relazione.
“La disciplina in vigore – spiegava il documento governativo – risale per la gran parte alla originaria legge sull’equo canone (legge n. 392 del 1978) e, nonostante alcuni interventi di riforma, continua a presentare rilevanti elementi di rigidità che non hanno pari nei principali Paesi europei. L’evoluzione del sistema economico ha inoltre portato a constatare come le originarie esigenze di tutela, che vedevano aprioristicamente nel conduttore il «contraente debole», risultino largamente superate. L’attuale disciplina vincolistica limita la libertà delle parti di regolare liberamente il rapporto, predeterminandolo in molti elementi essenziali (ad esempio vincoli alla durata, ipotesi inderogabili di recesso del conduttore, limitazioni alla possibilità di prevedere liberamente le modalità di revisione del canone, ipotesi inderogabili di prelazione eccetera). Tali rigidità rendono meno appetibili gli investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri e costituiscono un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili ad uso turistico”.
Parole sante, che tuttavia accompagnavano una norma che – come anticipato – provvedeva a rimuovere le rigidità e i vincoli denunciati dall’esecutivo dell’epoca (guidato da Matteo Renzi) solo a una parte limitatissima dei contratti di locazione, probabilmente quelli che meno ne avevano bisogno. In questo quadro si inserisce la novità della delega fiscale, che segue un esperimento varato nel 2019, quando l’opzione per la cedolare secca (al 21%) fu prevista, dal primo governo Conte (su impulso della Lega), per i soli contratti stipulati in quell’anno e limitatamente ai locali commerciali di categoria catastale C1 e con superficie fino a 600 metri quadrati.
La parola passa ora ai decreti delegati, nell’ambito dei quali il principio introdotto nella legge delega andrà tradotto in norma cogente. Gli aspetti da definire saranno diversi: contratti nuovi o in essere, immobili interessati, aliquota, ma anche necessarie distinzioni rispetto alla cedolare valida per le locazioni abitative. Nella normativa riguardante queste ultime, ad esempio, è prevista a rinuncia del proprietario alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto.
Nel caso delle locazioni a uso non abitativo – per le quali la durata è, di fatto, rimessa alla scelta dell’inquilino (la legge prevede 12 o 18 anni a seconda delle attività svolte nei locali ma contiene meccanismi tali da impedire qualsiasi libertà per i proprietari di chiudere il contratto anche dopo queste lunghissime durate) – una norma di quel tipo condannerebbe all’insuccesso il nuovo regime tributario.
Giorgio Spaziani Testa, 17 agosto 2023