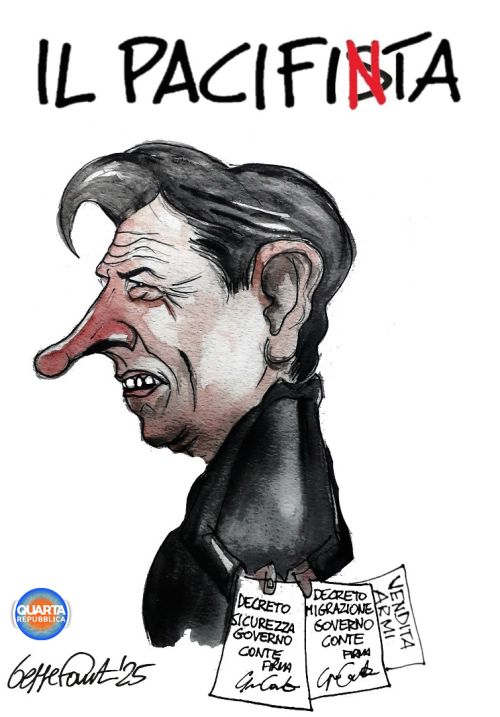Quello che è successo in Borsa ad Apple in queste ultime settimane non è una cosetta di poco conto. Non stiamo parlando di Tesla, un’azienda americana, che si è messa in testa di fare concorrenza ai giganti delle auto e che nell’ultimo trimestre del 2018 ha venduto poco più di 90mila vetture in giro per il mondo.
No, con Apple stiamo parlando di un’icona della tecnologia americana: migliaia di brevetti, una capitalizzazione di Borsa che aveva superato i mille miliardi di dollari (per capirsi la metà di tutta la ricchezza, il Pil, italiano), uno stile di vita e di new age, una sorta di fichizia planetaria che parte dal packaging e finisce con il prodotto in sé. In un paio di sedute ha perduto circa 400 miliardi dai suoi massimi di Borsa. Il tutto perché le sue vendite, comunque stellari, non sono andate come dovevano.
Il suo amministratore delegato, Tim Cook, una sorta di ragionier Filini se paragonato al fondatore Steve Jobs, ha detto che è colpa dell’andamento dell’economia cinese. Che in effetti non è andata come si sperava. Si tratta di una mezza verità, e i mercati lo hanno capito. In molti, dal punto di vista industriale, si sono infatti chiesti che senso avesse sostituire un prodotto da mille euro (iPhone X) con uno molto simile solo dopo un paio di anni. Un’altra pattuglia ha infine notato come Apple sia troppo «iphonecentrica»: non è riuscita a inventarsi molto oltre al melafonino negli ultimi anni. In fondo vende sempre quella roba là e per di più senza grandi salti tecnologici tra un modello e l’altro.
A questo punto si deve però notare che sono tutti bravi a fare gli analisti e gli espertoni, non solo di tecnologia, ma anche di management. Se tutta questa pattuglia di sapientoni del giorno dopo fossero così bravi e pieni di idee invece di prendersi il loro stipendietto alla fine del mese, forse avrebbero già messo su la nuova Apple. E così non è.
Il punto, banalmente, è forse proprio questo. Nonostante oggi per i colossi della tecnologia, dai produttori di smartphone ai gestori di piattaforme (Amazon o Facebook), il mercato è una brutta bestia: nel senso che fa il suo mestiere. Si sente spesso dire che occorre vigilare sotto un profilo antitrust su questi mostri del XXI secolo, ma poi non si fanno i conti sulla competitività e la concorrenza del mercato. I tecnici del settore dicono che tra la produzione di un oggetto (un pc o un telefonino) e la predisposizione di una piattaforma che si autoalimenta del suo successo, ci sia una differenza. Può essere: resta il fatto che nel bene e nel male questo dannato mercato è l’unica vera garanzia di una rigenerazione creativa della competizione economica. E sui telefonini ci sono due casi piuttosto emblematici.
La copertina di Forbes del novembre del 2007 era dedicata all’allora boss della Nokia, preso di profilo, con un suo telefonino ficcato nel suo orecchio. E con uno strillo di copertina: «Un miliardo di clienti – Qualcuno potrà mai raggiungere il re dei cellulari?» Solo qualche mese prima Jobs aveva presentato il suo primo iPhone che, nel giro di dieci anni, non solo aveva fatto fallire Nokia, ma aveva raggiunto anche essa il miliardo, non di clienti, ma di fatturato. Roba incredibile, allora. Solo dopo un anno, Apple si inventa il negozio virtuale. Saltano tutti gli schemi. E saltano tutti i competitor, compreso il Blackberry, della Rim.
Senza andare così lontano nel tempo, basta ricordare cosa è avvenuto in Cina, la stessa di cui si lamenta oggi Cook, in soli cinque anni. Lì a comandare c’era la Samsung: uno smartphone su cinque era targato coreano. Oggi sì e no, uno su dieci è loro.
La morale, in fondo, è solo questa. Nessuno, o pochi, oggi possono sapere se il tonfo di Apple in Borsa sia un primo segnale. Ma tutti noi dobbiamo sapere che la migliore sanzione al predominio delle grandi tech company si chiama mercato. Inflessibile, impietoso: nel giro di pochi anni può trasformare una mela in un torsolo.
Nicola Porro, Il Giornale 5 gennaio 2019