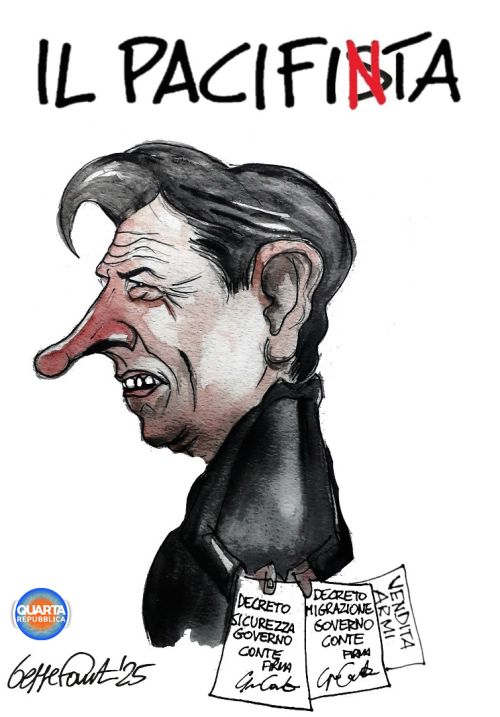In Italia i problemi non si risolvono, marciscono. Secondo Francesco Cossiga, ad esempio, la questione centrale della politica e delle istituzioni italiane è la giustizia che andrebbe riformata dividendo le carriere di pubblici ministeri e giudici ma è molto più facile che un cammello entri nella cruna dell’ago. Un nuovo patto fiscale è non solo vitale ma conveniente per tutti, sia per lo Stato sia per i cittadini, ma è molto più facile che nevichi in agosto. La riforma della Rai, con la fine della retorica intorno al mistero glorioso del “servizio pubblico”, è cosa decente ma è molto più facile che le cortigiane ridiventino illibate.
Cosa dire, poi, della scuola? Son più di cinquant’anni che il modello della scuola di Gentile, imperniata su liceo classico, scientifico e istituti professionali, è finita senza che si sia riusciti a dare un minimo di senso alla scuola di massa che, per paradosso, è tenuta su dallo stesso fattore che la butta giù: il diploma legale. Appunto, in Italia i problemi non si risolvono, marciscono.
Il marcio è dato non semplicemente, come si potrebbe esser portati a immaginare, dalla cultura statalista bensì dal perverso connubio tra individualismo e statalismo per cui da un lato i singoli e le categorie chiedono allo Stato protezione e assistenza e dall’altro lo Stato, cioè i partiti politici che di volta in volta governano, è ben lieto di allungare le mani su ogni cosa. Risultato? Lo conoscete benissimo: il fallimento di una nazione.
La cultura dell’individualismo statalista, come l’ho definita in un mio libretto, non solo ci impedisce di risolvere i problemi ma persino di vederli. L’individualista statalista pensa e agisce con un riflesso condizionato: se c’è un problema, allora, la soluzione è l’intervento statale. Non è mai sfiorato dal dubbio non solo che il problema abbia origine nella soluzione da lui invocata, ma che proprio il potente intervento statale sia in realtà impotente. Lo Stato, infatti, altro non è che un’azione violenta concordata – la forza della legge, la legalità – il cui scopo non è fare ma garantire la possibilità che gli altri, ossia la vita civile, facciano liberamente.
Quando lo Stato è portato fuori da questa sua specifica funzione accade che da un alto si cada nell’abuso e nel sopruso e dall’altro nella inconcludenza e nella vacuità. Lo si è visto in modo evidente, sempre per chi ha occhi intellettualmente onesti per vedere, anche nella crisi sanitaria del Covid-19 che proprio l’intervento statale ha trasformato prima in un abuso di potere con la negazione delle libertà e poi in un tragico festival dell’insipienza in cui è stata smarrita la sola cosa che andava e poteva essere garantita: la minima sicurezza sanitaria.
Le radici dell’individualismo statalista sono il cattolicesimo e il comunismo. Queste due culture, le più importanti del Novecento italiano, credono all’esistenza di istituti salvifici. Per il cattolicesimo è la Chiesa. Per il comunismo è il Partito. Ai loro occhi lo Stato è un potere che va conquistato per essere messo al servizio della salvezza. Il grillismo, che è l’ultimo prodotto della subcultura massificata della scuola di massa, è l’erede del catto-comunismo. Nasce così lo Stato-chiesa o lo Stato-partito, ma invece di avere la salvezza si ottiene la dannazione, come è naturale che sia quando si mischia sacro e profano o si vende l’anima al diavolo.
Ma tutto ciò che è pubblico non è statale: è altro rispetto allo Stato. La vita statale, diceva mirabilmente Croce, è moralmente angusta. E noi possiamo dire che è anche economicamente e culturalmente angusta, piccina, fino a diventare paradossalmente privatistica, feudale. Ecco perché noi non usciremo mai e poi mai da questo che Saverio Vertone, già ai tempi della Prima repubblica, chiamava l’ultimo manicomio perché la stessa cultura – scuola, informazione, Rai, ordini professionali – che alimenta il dibattito intorno ai problemi sociali e statali chiede a gran voce sempre un aumento del potere dello Stato e mai una sua limitazione.