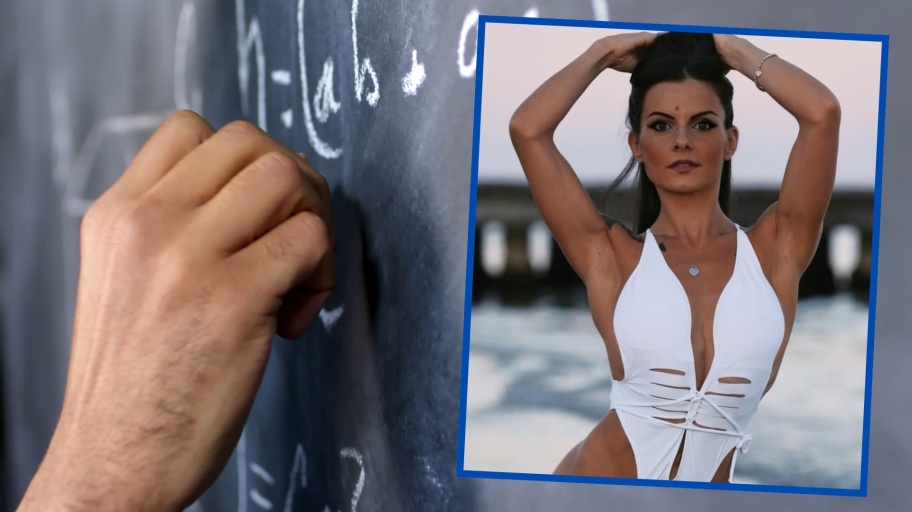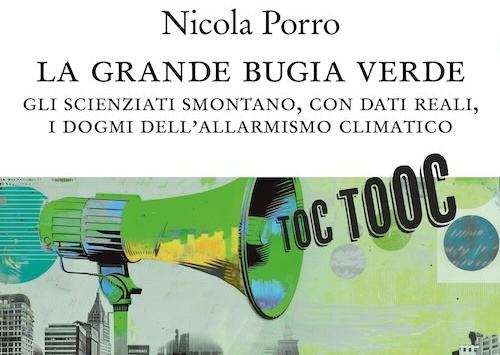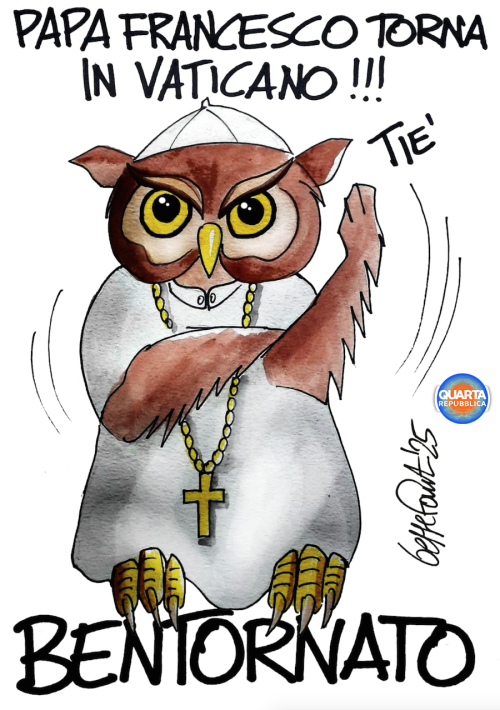Il codice etico per gli insegnanti è una cagata pazzesca. Un provvedimento profondamente illiberale, e per di più difficilmente applicabile al caso pratico, che si presterebbe, tra l’altro, anche a possibili “usi discrezionali” da parte dei “controllori” e fungere, eventualmente, da strumento di “ritorsione” per punire comportamenti e persino punti di vista sgraditi.
Del resto, essendo principalmente pensato per “vigilare” sull’attività social dei prof, il codice etico dovrebbe definire a priori quali sono gli atteggiamenti appropriati da adottare sul web al fine tutelare l’immagine e il buon nome delle istituzioni scolastiche, e quali, invece, quelli da evitare assolutamente, a meno di voler correre il rischio di incappare in un provvedimento disciplinare.
Una vera e propria stretta che, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe giovare ad evitare, o perlomeno a limitare, il verificarsi di situazioni “spiacevoli” tali da poter creare imbarazzi alle istituzioni scolastiche. Come nel recente caso dell’insegnante trevigiana beccata ad “arrotondare” su una piattaforma web dedicata a servizi di intrattenimento per adulti, per intenderci. Ma l’intervento normativo in questione, chiaramente, non potrebbe rivolgersi alle sole attività eventualmente erogate su piattaforme per adulti, come avvenuto nel caso appena citato, bensì, tenderebbe ad introdurre dei paletti su tutta l’attività web del personale scolastico, siano essi immagini, commenti o dichiarazioni, al fine di evitare che l’utilizzo “allegro” dei social possa incidere sul livello sociale ed emotivo degli studenti o, come detto, danneggiare il prestigio dell’amministrazione.
Leggi anche:
- Perché sto con Elena Maraga, la maestra di OnlyFans
- Ma anche la scuola sia libera di cacciare Elena Maraga
Sulla base di tali presupposti, tuttavia, il rischio che a finire nel mirino del Sacro Tribunale dell’Etica e della Morale siano, tra l’altro, anche le libere opinioni personali dei docenti appare serio e concreto. Senza contare l’eccessivo livello di discrezionalità che si attribuirebbe ai controllori, nelle cui mani dovrebbe essere rimesso il supremo compito di stabilire dall’alto se un’immagine o un commento è lesivo della reputazione dell’amministrazione o nocivo per gli studenti, o meno. Una condizione che, pertanto, potrebbe dare luogo ad “usi distorti” o, peggio, finire per scadere nell’ideologismo, senza peraltro garantire il pieno rispetto della norma.
Perché quindi non limitarsi ad intervenire sul caso concreto, data anche l’esistenza di un regolamento del 2023 che già disciplina l’uso dei social media per i dipendenti pubblici, piuttosto che avventurarsi nella ricerca spasmodica di nuovi divieti e restrizioni utili solo ad appesantire ulteriormente il carico normativo, senza tuttavia risolvere il problema, anzi, probabilmente, creandone pure di nuovi?
E ancora, che senso avrebbe, anche sotto un profilo politico, seguire gli umori “punitivi” della piazza, e lasciarsi inevitabilmente cucire addosso l’etichetta dei despoti che vogliono ad ogni costo “imbavagliare” i docenti, quando le fortune elettorali dell’esecutivo, è bene ricordarlo, sono state costruite proprio sul tema delle libertà nel momento di massima compressione dei diritti individuali?
È veramente così difficile comprendere che gli elettori hanno scelto questo governo anche e soprattutto in nome della libertà e della sburocratizzazione, e contro quelle logiche, al tempo imperanti, fondate sulla sorveglianza universale e sulla restrizione preventiva? Evidentemente sì, lo è, almeno a giudicare dal contenuto di certe proposte.
Salvatore Di Bartolo, 29 marzo 2025
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).