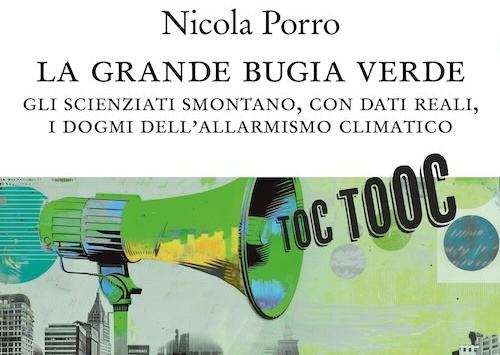Guardarsi allo specchio non è sempre stato vedere la fedeltà della propria immagine. Al contrario, aspiciere ad speculum, voleva significare osservare la propria immagine tràdita dall’inganno della realtà. Si trattava infatti più di un aspectum che di uno speculum, ossia del proprio “aspetto” più che uno “specchio”.
Il termine “specchio” si è fatto in seguito, per tradizione tardoantica, conduttore di un’altra valenza semantica, propriamente quale oggetto atto all’uguaglianza del riflesso, attraverso cui è possibile vedere la verità del reale che ci è nascosta. Ma se aspetto e specchio sono etimologicamente figli della stessa radice /-spekl-/ che indica l’idea dello “sguardo”, cosa significa davvero allora “specchiarsi”?
Nelle Metamorfosi di Ovidio il giovane Narciso dopo che scopre una fonte acquifera all’interno di un floridissimo angolo silvestre, non resiste dall’inclinarsi verso la fonte per osservare la limpida purezza dell’acqua, ma scopre il suo volto poiché riflesso nell’acqua. È risaputo dalla vulgata letteraria postuma del mito ovidiano l’epilogo della vicenda del giovinetto. Narciso si innamora della sua illusione e fugge dal suo amore Eco. Il giovinetto prima inconsapevole della sua bellezza non si era mai riflesso nella realtà, ed è questa che lo porta infine alla rivelazione del tabù che sortisce il duplice effetto dell’ambiguità. Da un lato infatti egli morirà consunto come uomo e vegeterà come un fiore, dall’altro la ninfa Eco si annienterà nella sua stessa illusione e vagherà nel nulla come un suono. Si profila qui perfettamente l’esempio del presagio funesto che riassumeva in sé l’ambiguità dello specchio.
Lo stesso Achille a Sciro, nella narrazione che ne fa Stazio nell’Achilleide, durante la visita fraudolenta che gli fece Odisseo e Diomede alla corte di Licomede, quando si riflesse nel bronzo dello scudo che gli donò l’eroe itacense, divenne mantis (indovino) del proprio destino, riconoscendo la gloria e la morte che lo attenderanno a Troia. In entrambi i casi, l’uno per il corpo, l’altro per lo spirito, è la bellezza a generare la morte, tanto che il classicista Giampiero Rosati ha parlato in un suo saggio datato 2016 di una “illusione e spettacolo”, parziale titolo dell’opera, che nel parallelismo di Narciso e Pigmalione sono portatori mortali di bellezza. La sedimentazione dei secoli successi sino a noi dello strato più sotterraneo dell’idea dello specchio, connesso sempre di meno con l’aspetto “attivo” e sempre di più col riflesso “passivo”, quasi involontario, ha spostato l’asse della gnosi da un livello anagogico a uno allegorico, trasponendo gradualmente sul piano dell’Arte la dimensione metatestuale nella riduzione ipotestuale.
L’avvento della rinascenza carolingia del IX secolo d.C ha notevolmente accelerato questa conversione del segno gnostico, sradicandolo da ogni sua ambiguità che risultasse, naturalmente per antonomasia, pagana. Lo speculum principis ne è la manifestazione più superficiale e immediata. Tuttavia si ruppe quello schema così univoco della vista intesa come percezione estetica umana, quando essa sotto l’impulso della poesia polizianesca alla corte medicea e della pittura raffaellesca alla corte urbinate, ritornò ad avvicinarsi al senso di fragilità della ragione umana. E lo fece con l’esempio magistrale dell’Ariosto nella corte estense di Ferrara. Il bellissimo meccanismo di toccata e fuga che oscilla nei versi dei Furioso tra ironia e utopia, trasmetterà la distanza di quell’impianto prospettico lunare alienante al Caravaggio ancora romano da cui formulerà il Narciso riflesso. È qui l’acqua a estromettere, come poco più di un semplice riflesso, l’inconscia vanità efebica di Narciso e superare il varco speculare del riflesso fisionomico.
Tiziano più tardi proporrà una Venere allo specchio (1555-57) che aprirà un ventaglio di squilibrio razionale nello spettatore, ritentato nello stesso soggetto da Rubens negli anni 1613-14 e infine diffusore di un nuovo senso di “riflessione temporale” con l’omonima Venere di Velazquez (1648-50). Ma lo specchio continuerà a modellare un nuovo sguardo nella pittura successiva, fino a soggiornare permanentemente nell’atelier di Pablo Picasso, memore del ruolo che questo oggetto ha giocato nella recente pittura impressionistica, come elemento procreatore dell’immagine nel tempo. Dall’interiorizzata idea dello specchio come effusore multilaterale del presente, nasceranno opere come Les Damoiselles o la Dama col Ventaglio, sino a giungere al manifesto del formalismo astratto che Guernica.
Il relativismo formale annunciato dall’icona picassiana è creditore di tutta la cultura astrattista che si aggrumerà dopo in Europa, e in Italia attorno alla figura di Renato Guttuso. Al tempo stesso il suo credito sarà quello di una storia dell’Arte che in qualche maniera dovrà d’ora in poi esplicarsi sempre attraverso una lente concettuale secondaria, che la renda indiretta, distaccata formalmente dalla realtà per sintetizzarla. Una dimensione quindi speculare, binaria da cui l’arte non tange il reale, ma lo interpreta, così come i cristalli sregolati di uno specchio. Da Picasso in poi l’Arte è specchio, e non imitazione del reale. Per questo Del Puppo parla di naturalismo formale per riferirsi all’ astrattismo di fine Novecento.
Il distacco però che separa l’arte contemporanea dalla realtà, come sua speculare, ha sacrificato la complessità intertestuale dello sguardo, e quindi il concetto tutto umano e terreno di specchio. Lo sguardo aveva perso in questa distanza incolmabile e irriducibile, il tabù. Esso ha invece cambiato il soggiorno presso l’atelier lucano di Antonio Telesca, da dove ha riacquistato attraverso una profonda metamorfosi spirituale la dignità di presagio mortale nell’elemento tabù.
Il pittore acheruntino che a differenza dei contemporanei Cattelan e Jago concepisce una composizione in dialogo serrato con quella che Platone chiamava demiourghia, ossia la techne del demiurgo, colui che interpreta e crea per il pubblico, ha riportato a terra la sinestesia mimetica dello sguardo attraverso Alieno. Un acrilico che stigmatizza una tela 120×120 cm, perfettamente quadrangolare, in cui è quasi epigrafata una effige di un genere che non tarderemmo a definire disumano, o appunto a noi alieno.
Una sagoma che contorna al tempo stesso un’ombra policroma, dietro la quale non sarebbe possibile avere la certezza si nasconda un volto umano, un profilo animale o vegetale, o forse, una anomalia dell’essere, scarica dal groviglio il potere dell’apparenza. Ai lati sembrano scorgere due brevi protuberanze che alluderebbero, in chiunque è capace di guardare, e dunque possa dirigere uno “sguardo” che sia per tale supposto umano, ai caratteri anatomici del naso e dell’orecchio.
Sebbene alcuni tratti iconografici come quello del volto, nel suo senso epistemologico participiale di vultus, indeterminato e trascorrente, riferiscano l’opera a una ricezione surrealista e ancora neocubista, è da notare come il segno che Telesca usa è quello anadiplodico, dell’enfasi grafica spezzata. L’anadiplosi del segno concorre nella composizione a rendere la suggestione di un incanto ipnotico nello spettatore, a immobilizzare gli occhi per poi lasciarli smarrire dietro le concentriche serpentine.
L’effetto di disordine materiale che suscita all’occhio non è d’altronde quello nervosamente astratto che mira alla complessione dei piani, ma è quello che da una parte rintraccia la sincronia neocubista dei momenti prospettici insieme alla bilaterale simultaneità, dall’altra invece avoca a sé il canale hegeliano del piacere per projectum. Tre teste sono accorpate in un’unica dimensione, così come lo sono tre sguardi e tre tempi di fronte a uno specchio fagocitante. E il nostro sguardo è indotto da Telesca in un iter fenomelogico per cui si parte dall’impressione razionale, dal segno spaziale, e si diparte via dall’irrazionale, dal segno temporale, verso quello stesso spazio sublunare ariostesco. La finzione testuale che copre interamente l’opera fa immaginare verità aliene all’uomo, così come lo è l’identità di quello sguardo che riflette anonimo quello di chi prima guarda e poi partecipa.
Alieno è il mondo che pertiene al sapere terenziano dell’uomo, ma quello in cui l’uomo riconosce il proprio destino, come Achille allo specchio del suo scudo. Alieno è lo sguardo verso il proprio destino. Alieno di Telesca è l’elemento gorgoneion che conduce all’apotropaico, quaggiù dove il futuro è della sorte sempre il tabù.
Mauro Di Ruvo, 23 marzo 2025
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).