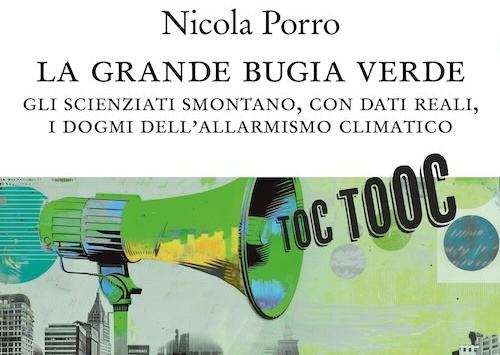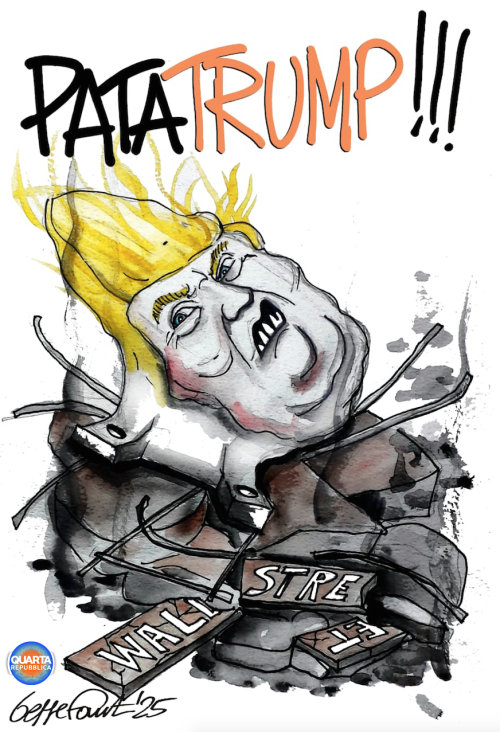Di Raffaello giovane conosciamo veramente molto poco. Non ci è giunta una puntuale e coerente documentazione della sua formazione in Umbria da parte delle fonti coeve, né della sua effettiva permanenza nella terra del suo maestro Perugino. Soltanto qualche contratto firmato da tutori in sua vece o da suoi collaboratori, tra cui lo stesso Pinturicchio. Ma molti dei dati cronologici che affermano alcune fonti sono contraddetti da altre ancor più vicine al suo contesto familiare e all’editoriale peruginesca, aggravando ancora di più il contraddittorio tra storici e critici sulla paternità delle opere giovanili dell’urbinate.
Una cosa è però sicura, e cioè che dopo gli ultimi per i Baglioni a Perugia e le ultime commissioni a Orvieto in associazione col Signorelli, Raffaello dovette partire per Firenze e da lì inoltrarsi in una serie di viaggi e soggiorni nell’Italia centro-settentrionale che includeranno anche la laguna veneta.
Il ventiduenne urbinate trarrebbe proprio da queste frequentazioni policulturali e politecniche una nuova maniera che diventerà quasi del tutto estranea alla disciplina del maestro Pietro.
In uno dei prodotti fuoriusciti dalla novella mano del “divin pittore”, dobbiamo inserire forse il più controverso della sua autografia: la Fornarina. Ne abbiamo sentito parlare più volte, forse anche meno della Monnalisa del contemporaneo Leonardo. Eppure il dibattito sulla vera identità della ragazza ritratta nel dipinto che Raffaello fece nel 1518 d’incerta committenza, rimane forse non più un così fitto mistero.
Per tutti questi anni, a partire dalla revisione storiografica del Longhi, è valsa la denominazione del quadro di Fornarina sotto l’effetto psicotico che il Vasari lascia in chiunque storico lo legga e lo riprenda testualmente, mentre oggi dovremmo iniziare a chiamarla con un altro nome ben diverso dalla sua fortunata traditio. Ma quale? La risposta non solo risponderebbe alla questione identitaria che ha diviso alacremente la critica, su cui ultimo Alessandro Cosma che riprende l’Oberhuber (2002), bensì anche al dilemma iconografico che si protrae in Raffaello sin dalla Loggia di Galatea in Villa Farnese del 1512. A ciò si aggiungerebbe un ulteriore tentativo di chiarimento cronologico che va a sciogliere il complicato nodo politico della Velata e della Loggia di Amore e Psiche.
Si tratta di prendere delle distanze chilometriche dalla interpretazione allegorica del forno sulla verosimile idea di cortigiana, comunque parallela all’alternativa vasariana, ossia della probabile figlia del fornaio senese Francesco attivo a Trastevere. E accettare invece la figura femminile attorno cui s’era creato uno degli scandali più vistosi di Roma all’interno della famiglia Chigi. Francesca Ordeaschi è non solo la “sposa invisa” del ricco banchiere dalle mire mecenatistiche Agostino Chigi, ma sarebbe anche la intestataria di molte opere di Raffaello seguitesi tutte in quel decennio 1512-20.
É alla dama Francesca Ordeaschi che era stato infatti dedicato il ciclo allegorico degli affreschi della loggia di piano terra della residenza di Agostino Chigi, alla quale il “divin pittore” ci lavorò tra il 1516 e il 1518. Il soggetto decorativo è quello del mito apuleiano di Eros e Psyche, che si innesta qui cronologicamente proprio nell’anno in cui Agostino e Francesca, entrambi già genitori di figli illegittimi, decidono di convolare a nozze. Agostino dunque chiamerebbe proprio Raffaello per illustrare sotto il velo simbolico della pittura tutte le vicende, secondo l’ultima analisi di Amélie Ferrigno, che hanno dato a pettegolezzi e infamie sulla loro storia sentimentale.
L’inizio cronologico di questa storia segreta tra il banchiere mecenate e la Ordeaschi rivestirebbe, se soltanto lo conoscessimo con sicurezza, una certezza sulla genesi iconografica della Galatea, ancora più illuminante della metamorfosi stilistica di Raffaello segnata dall’esperienza di fine decennio nella Loggia del ciclo allegorico-mitologico.
Ma chi è Francesca Ordeaschi? Anche di lei non si posseggono molte notizie, anzi quasi nessuna, se non quella per cui il Chigi l’avrebbe incontrata prima del 1512, l’anno prima, a Venezia in occasione di una mediazione papale col Doge, e da lì l’avrebbe portata come “trofeo” a Roma invitandola nella sua residenza privata. Dal racconto dei biografi del Chigi e dalle notizie documentate dal suo entourage papalino, sarebbe inizialmente trascorso tra i due un rapporto adultero che darebbe alla donna veneziana una probabile provenienza cortigianesca e comunque non di livello borghese al quale apparteneva il banchiere senese. Dopo aver dato lei alla luce un figlio illegittimo, l’amicizia col papa Leone X per Agostino inizia a incrinarsi insieme a un divorzio familiare totale dal fratello e dalla famiglia, che ne risentiva profondamente dello scandalo sia per la banca che per l’onorabilità pubblica. In occasione dunque del matrimonio suggerito dal pontefice per riparare alla foschia della sua immagine presso l’ambiente romano, viene chiamato Raffaello nuovamente a decorare un’altra loggia della sua villa, ma stavolta con le storie di Amore e Psiche.
Il cambiamento dello stile pittorico del maestro urbinate non costituirebbe un problema filologico della stessa importanza della contaminazione giorgionesca e tizianesca nell’esecuzione delle due scene centrali della loggia. Sarebbe a dire l’impiego di tecniche familiari e peculiari dell’ambiente veneto, e nello specifico veneziano, il contesto ossia da cui proverrebbe la stessa Francesca dedicataria dall’opera a cui sta egli lavorando e che Raffaello avrebbe dovuto praticare almeno dal 1512 per la realizzazione della Galatea, in cui emergono le prime reminiscenze d’area veneta.
Tra l’altro nella Galatea è visibile il primo ricorso figurativo del volto che noi troviamo identico successivamente nella Velata, lavoro contemporaneo all’Estasi di Santa Cecilia, in cui anche è riconoscibile il volto della ninfa nella Maddalena, per proseguire poi nella Fornarina e nel Ritratto di giovane donna che è databile in quegli stessi anni 1519, forse l’inizio e l’allocazione, e 1520, anno in cui muore il Chigi, qualche mese dopo il dipinto compiuto (dicembre ’19-febbraio ’20).
A prescindere tuttavia dalla analogia fisionomica che troviamo nel dipinto della Fornarina, ormai assodata, ci interessa notare, a fronte anche di quanto ben messo in luce dal recente studio della Ferrigno, che il trattamento con cui è stata composta la figura femminile afferisce all’iconologia nuziale cinquecentesca, per numerosi tratti distintivi che marchiano l’opera come ritratto d’occasione, diremmo post-nuziale.
Per due elementi quali il copricapo lussuoso tipicamente maschile da cui pendono i tre gioielli impilati, ognuno dei quali ha un suo valore rituale nel contesto nuziale, e la rappresentazione anti-convenzionale del corpo nudo di tre quarti che propone più erotismo carnale che castità matrimoniale (come nella Velata), dobbiamo ritenere che si tratti di una donna di originaria estrazione non elevata ma promessa sposa al un soggetto di rango borghese. Tuttavia in un contesto non tipicamente istituzionale, cioè vestita, ma personale e privato, quasi da camera da letto. Nel dipinto la componente veneta e gorgionesca esalta non indifferente all’occhio del contemporaneo spettatore, così come la stoffa che le copre il capo.
Non è dunque un dipinto da esporre pubblicamente come propemptikon del matrimonio, ma è il primo nudo dipinto da Raffaello nel genere della ritrattistica dal vero, e perdipiù con così accentuata libidine erotica. Simile alla personalità del suo genio raccontata dal Vasari, per cui mentre operava alla loggia avrebbe richiesto d’obbligo e d’esigenza la presenza della sua amante preferita, di cui però non sappiamo nulla. Per alcune carte pubblicate però della biografia del banchiere, risulterebbe che egli avesse incaricato Raffaello, nel giro prossimo di quegli anni in cui aveva concluso la decorazione nuziale, un altro ritratto della sua “amata” da tenere privatamente per suo piacere.
Conoscendo i gusti spinti e priapei del Chigi, anche dal genere dei festoni dipinti da Giovanni da Udine, non sarebbe una meraviglia che fosse stata affidata a Raffaello una particolare e inconsueta rappresentazione nuziale dI Francesca Ordeaschi nel 1519, in stretta prossimità del banchetto nuziale. Molti elementi ci inducono a confermarlo, pur senza spiegarci l’imbarazzo che avrebbe provato il pittore per quel genere di committenza quasi incestuosa.
L’ultima conferma ci viene dal paradosso del bracciale dipinto sul braccio sinistro della modella, su cui è iscritta la firma di «Raphael Urbinas», un unicum nell’opera omnia del pittore. Raffaello ha dovuto sentire profondamente suo quel dipinto non solo come capolavoro assoluto dell’arte, ma anche come perfetto ricordo del suo eros, vera chiave e matrice della sua bellezza.
Così il volto della Galatea ritrovato nella Fornarina si spiegherebbe dalla conoscenza pregressa che ci sarebbe stata, se non in precedenza, ma in concomitanza col Chigi, nel 1511 tra Raffaello e l’amante ufficiale di Chigi. Una amante tenuta anonima come anonimo è stato tenuto il dipinto della Fornarina per tutto il Cinquecento, e ricomparso soltanto a fine secolo, ma anche rimaneggiato di uno stemma Chigi scomparso, perché appunto cancellato.
Francesca Ordeaschi sarebbe stata l’amante prediletta di Raffaello, quella per cui si è conservata una traditio formae in molte delle sue opere, quella stessa che viveva a palazzo del banchiere, e che sarebbe entrata in triangolo erotico, degno di silenzio e scandalo, fino alla decisione delle nozze riparatrici, a cui ha dovuto per forza collaborare il pittore, che avrebbe messo l’ultimo sigillo del suo amore in quel dipinto. Raffaello muore il 6 aprile 1520, pochi giorni prima di Agostino Chigi, dell’11 aprile. Dopo un anno morirà anche Francesca Ordeaschi, per una causa mortis dello stesso enigma, «eccessi amorosi» dice il Vasari, che ha coperto la fine leggendaria di Raffaello.
Una leggenda che non avrebbe potuto avere motivo di creazione se il Raffaello angelico che conosciamo attraverso i suoi dipinti non fosse stato invece un fedele accolito dell’ars amatoria ovidiana. Un Raffaello non eròmenos, ma erastès. Un illustris Raphael amans.
Mario Di Ruvo, 1° aprile 2025
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
 © beachboy tramite Canva.com
© beachboy tramite Canva.com