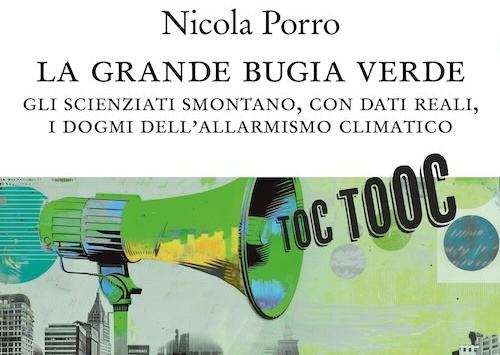A Monfalcone, Comune già noto per l’alta percentuale (30%) di stranieri residenti e per la decisione di alcune ragazze di andare a scuola velate, il 13 e 14 aprile si va al voto e tra i candidati c’è anche Bou Konate, già assessore del centrosinistra, che correrà con una lista composta interamente da stranieri.
Per i progressisti, il problema del razzismo è riconducibile essenzialmente a una questione estetica, il “colore della pelle”, la diffidenza verso il diverso, e a una questione morale, il dovere di solidarietà verso le persone più disagiate. Per i conservatori, il razzismo è giustificato dalla necessità di tutelare l’identità nazionale (l’etica di una nazione) e di non sottrarre risorse destinabili alle classi meno abbienti della propria società.
A mio parere, entrambi gli schieramenti non colgono l’essenza del problema, che è rappresentata dall’etica. L’etica è l’insieme dei coefficienti sociali che una collettività, più o meno allargata, condivide per limitare i conflitti interni. Una società che non ha un’etica condivisa non è una società: è destinata a disgregarsi a causa dei conflitti interni che ne determinerebbero il disfacimento.
La forza di coesione dei valori etici è dimostrata dalla resilienza che le società mostrano di fronte agli attacchi finalizzati a dissolverle: guerre, deportazioni, violenze di ogni genere, pulizie etniche faticano ad annullare una società che si basi su radicati coefficienti sociali condivisi. Per scalfirli è necessario inculcare altri valori sociali, basati su falsi storici, indottrinamento, censura e cancel culture. È inoltre necessario spazzare via i simboli del passato: opere d’arte, letteratura, monumenti, religione.
Allora, perché i segnali di “razzismo” si manifestano nei confronti, ad esempio, dei magrebini, che sono fisicamente in tutto e per tutto uguali a noi, e non degli ucraini? Abbiamo veramente paura delle diverse sfumature del colore della pelle? E questa paura giustificherebbe la reazione di rifiuto verso popolazioni diverse da noi? In realtà, la diffidenza, o addirittura il rifiuto del diverso, sono dovuti essenzialmente al timore, a livello istintivo, che l’accoglienza nella nostra società di popolazioni che non condividono la nostra etica, o che in molti casi hanno valori antitetici ai nostri coefficienti sociali, porti inevitabilmente alla disgregazione della nostra società. Il rischio di disgregazione, ovviamente, è legato esponenzialmente al numero degli immigrati che si inseriscono nella nostra società. Se il loro numero è elevato, è fisiologico che si creino aggregazioni chiuse di immigrati all’interno della popolazione che li accoglie, finalizzate alla tutela e alla condivisione dei loro valori, dei loro coefficienti sociali (associazioni chiuse dei beneficiati all’interno della società dei beneficianti). Il che potrebbe anche non essere negativo, a patto che gli ospiti rispettino i seguenti principi [1]:
– sia riconosciuto il concetto di beneficiato e di beneficiante;
– il beneficiato ricambia il beneficiante e riconosce di essere in debito;
– le associazioni che creano siano volontarie e non esclusive (associazioni aperte).
Gli ospitanti, dal canto loro, devono:
– ritenere “veri” i propri principi e credenze (etica);
– concedere ad altri di coltivare “credenze sbagliate”, fatti salvi i presupposti di cui sopra.
Torniamo quindi al problema dei magrebini e degli islamici in generale: i loro coefficienti sociali sono basati su una visione del mondo teocratica, sulla negazione dei diritti dell’uomo, sul ritenere che chi non è islamico sia un infedele. È evidente che i loro valori siano del tutto antitetici ai nostri. Perché la reazione xenofoba non si manifesta verso altre popolazioni, ad esempio gli ucraini? Perché i loro valori sociali si basano sulla cultura giudaico-cristiana, che garantisce una non conflittualità con i nostri valori etici identitari di base. È possibile convivere con la cultura islamica? Sì, a patto che beneficiati e beneficianti rispettino i principi di cui sopra.
Il modo migliore per acuire la xenofobia è negare il problema e colpevolizzare chi prova disagio verso gli immigrati islamici e chi vuole difendere i propri valori. Una parte consistente degli italiani avverte questo disagio, ma non ha gli strumenti culturali per comprenderne le ragioni. L’altra parte della società, per non sentirsi “colpevole”, accetta acriticamente l’accoglienza, al punto da relativizzare i propri valori o addirittura considerarli disvalori.
Per evitare la divisione della nostra società tra “buoni” e “cattivi”, sarebbe necessario definire il problema su basi razionali, cioè senza rinnegare l’esistenza di valori etici condivisi, e chiarire quali strumenti di accoglienza si intende mettere in atto per garantire il rispetto dei principi sopra citati. Ciò eliminerebbe la partigianeria e la divisione ideologica della società, cosa non gradita ai nostri politicanti, che non avrebbero più argomenti per imbonire i loro elettori, sia a destra sia a sinistra.
Una condivisione, la più ampia possibile, degli strumenti che si intendono adottare per accogliere gli stranieri, garantendo allo stesso tempo l’integrità dei nostri coefficienti sociali, farebbe diminuire l’apprensione causata dal fenomeno migratorio e la sensazione di invasione. Infatti, un altro aspetto che non può essere ignorato è che l’aumento quantitativo di un fenomeno ne determina anche un cambiamento qualitativo (Hegel): l’accoglienza di un numero “contenuto” di immigrati non allarma nessuno; l’arrivo in massa di stranieri, senza fissare alcun limite quantitativo, dà la percezione di invasione.
Sul piano empirico, c’è poi da sottolineare che in nessuno Stato occidentale è pienamente riuscita la creazione di una società veramente pluralista, ossia una società che riesca ad affermare i propri valori e, allo stesso tempo, a tollerare valori diversi (fatti salvi i presupposti di cui sopra). Questo dimostra quanto sia essenziale l’etica per una società e quanto sia difficile modificarla in tempi rapidi (meno di una generazione).
La tecnica e la comunicazione, prevalentemente nel mondo occidentale, hanno dato una spinta impressionante all’evoluzione dell’etica delle società, che sono sempre meno differenziate e sempre più allineate a valori sociali finalizzati alla cultura nichilista (tutto ha vita effimera e deve quindi essere consumato). Ma questa accelerazione spesso causa disorientamento, perdita di identità, di punti di riferimento e di valori comuni. Tutto ciò accelera il processo nichilista della società occidentale. L’etica, infatti, può avere confini più o meno ampi, ma non così ampi da perdere il suo significato identitario.
Carlo MacKay, 11 marzo 2025
[1] Giovanni Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei, Rizzoli (2002)
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
 © Pro Creators e Dean Drobot tramite Canva.com
© Pro Creators e Dean Drobot tramite Canva.com