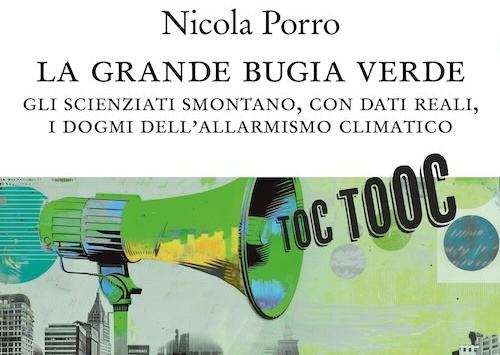Ricordo nitidamente la prima volta in cui, da giovanissimo sottotenente di complemento, portai un plotone di carabinieri allo stadio Olimpico per un servizio di ordine pubblico. Ero orgoglioso di rappresentare lo Stato, l’ordine, la sicurezza e credevo che questo sarebbe stato apprezzato da tutti i presenti. Invece, appena ci affacciammo nell’anello assegnato, fummo accolti dal coro di migliaia di persone: «la disoccupazione vi ha dato un mestiere, mestiere di merda, carabiniere!».
Credendo perfino di aver sentito male, mi girai verso un maresciallo molto più esperto di me per chiedergli quale fosse, a quel punto, il protocollo. Con tono tra il divertito e il rassegnato, mi rispose: «non si preoccupi, tra poco si abituerà e non ci farà più caso». Aveva ragione, tranne sul fatto che non smisi mai di farci caso, anche perché il coro era spesso accompagnato dal lancio di oggetti o di monetine (e non erano una donazione).
Ho ripensato a quel pomeriggio di 28 anni fa l’altro giorno, quando, in un trafiletto di giornale, ho letto di uno studente universitario che aveva pubblicamente apostrofato tre poliziotti, intervenuti dopo averlo visto inveire contro due donne, con le parole “servi, ignoranti e morti di fame” e li aveva invitati ad andare “a Gaza, per guadagnarsi lo stipendio”. Il risultato? Lo studente ha evitato qualsiasi conseguenza penale semplicemente versando la somma di tremila euro e scrivendo una lettera di scuse, chissà quanto sincera.
Ora, secondo l’articolo 341-bis del codice penale, chiunque offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni. Tuttavia, il legislatore ha introdotto un meccanismo di estinzione del reato qualora l’imputato, prima del giudizio, risarcisca il danno sia le persone offese che l’ente di appartenenza.
La monetizzazione dell’oltraggio
Va bene che viviamo in un Paese che nel 2016 ha abrogato il reato di ingiuria, depenalizzando il turpiloquio, ma l’idea che un’offesa grave all’autorità possa essere sanata con un pagamento resta per me inaccettabile (infatti, giustamente, questa opzione non è consentita per l’oltraggio di un magistrato in udienza). L’autorità statale e il prestigio del pubblico ufficiale non possono essere oggetto di transazione economica. Peraltro, nel caso in esame, il danno arrecato è stato quantificato, in media, in 750 euro per ogni agente coinvolto, considerato che il risarcimento è stato rivolto anche alla Polizia ferroviaria.
Questa impostazione è altresì profondamente iniqua: chi possiede risorse finanziarie adeguate può permettersi di insultare impunemente un appartenente alle forze dell’ordine, mentre chi non ha mezzi economici rischia una condanna penale. Si configura così un sistema di “sanzione selettiva” in cui l’accesso alla giustizia diviene una questione di disponibilità economica, in palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione. Non solo: una persona benestante potrebbe teoricamente coltivare il vezzo di insultare tutti i poliziotti che incontra e farla sempre franca.
Il ruolo marginale della parte offesa
Un ulteriore aspetto critico della norma riguarda il ruolo passivo del pubblico ufficiale offeso nella procedura di estinzione del reato. È il giudice a stabilire la congruità del risarcimento, non essendo prevista la possibilità per l’agente e per la sua Amministrazione di valutarne l’adeguatezza rispetto al danno morale e istituzionale subito.
Inoltre, la formulazione del reato presenta restrizioni discutibili: l’oltraggio è punibile solo se avviene in luogo pubblico e in presenza di almeno altre due persone che abbiano effettivamente percepito l’offesa rivolta al pubblico ufficiale. Ne consegue che le offese rivolte in un luogo non aperto al pubblico o senza la presenza di almeno due testimoni diversi dal pubblico ufficiale offeso non sono sanzionabili. Tali limitazioni appaiono prive di un fondamento logico coerente con la ratio legis, escludendo dalla tutela situazioni in cui l’offesa è altrettanto grave e lesiva dell’autorevolezza dello Stato.
Riformiamo la norma
A mio modo di vedere, l’abrogazione del quarto comma dell’articolo 341-bis costituirebbe una riforma semplice, a costo zero e con un forte impatto morale. Sarebbe necessaria per garantire un’effettiva tutela del pubblico ufficiale e, più in generale, dell’autorevolezza dello Stato. La possibilità di estinguere il reato attraverso un semplice risarcimento mina la credibilità delle istituzioni e trasmette un messaggio di deresponsabilizzazione per condotte altamente lesive della funzione pubblica. Qualora si volesse mantenere una forma di riparazione estintiva del reato, dovrebbe almeno essere la parte offesa (agenti e Amministrazione) a valutare la congruità dell’indennizzo, riconoscendole magari il diritto di opporsi all’effetto estintivo dello stesso.
Dottrina e giurisprudenza hanno già evidenziato le criticità di questa normativa, mettendo in luce come l’oltraggio a pubblico ufficiale non sia un’offesa al singolo individuo, bensì un attacco all’autorevolezza dello Stato. Il legislatore dovrebbe agire in coerenza con la necessità di rafforzare l’ordine pubblico, anziché adottare soluzioni che incentivano l’impunità.
Se il prestigio di un poliziotto è ridotto a una semplice questione economica, non dobbiamo sorprenderci se le istituzioni vengono trattate con crescente disprezzo. Lo Stato può fare di più per far rispettare chi lo rappresenta e lo difende.
Giorgio Carta, 11 febbraio 2025
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis)
 © piola666 tramite Canva.com
© piola666 tramite Canva.com