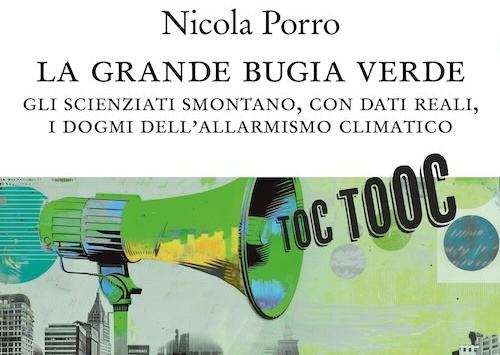Ogni possibile spiraglio di speranza per la fine la fine di una guerra è sempre una buona notizia. Tuttavia, la qualità della pace che ne consegue è un aspetto altrettanto fondamentale. Non tutte le paci sono uguali e non tutte sono giuste. Se non equa, almeno non dovrebbe essere disastrosa. Nel caso dell’Ucraina, il rischio è evidente: una pace costruita sulle necessità del momento, dettata più dalla stanchezza e dalla pressione geopolitica che da un reale equilibrio strategico, potrebbe tradursi in una resa mascherata da compromesso. Perché, al netto di ogni trattativa, un fatto resta incontestabile: Kiev non è contraente paritario, ma un Paese aggredito, allo stremo, costretto a difendersi contro un’invasione.
La scelta dell’Ucraina: strategia o costrizione?
Il recente dietrofront del presidente Volodymyr Zelensky, con l’apertura a una trattativa sotto l’egida di Donald Trump, solleva più domande che certezze. Si tratta di una scelta dettata da una valutazione strategica lucida o, piuttosto, dell’unico spiraglio rimasto a un leader sempre più isolato, con un esercito logorato e un sostegno internazionale in progressivo indebolimento?
La questione si fa ancora più complessa se si considera un altro elemento: l’Europa, a torto o a ragione, non è stata percepita da Kiev come un garante sufficiente della propria sicurezza. Se Zelensky ha scelto di affidarsi a Washington piuttosto che a Bruxelles, il messaggio è inequivocabile: l’Unione Europea, ancora una volta, dimostra di non avere né il peso politico né la solidità militare per imporsi come attore risolutivo nello scenario globale. Un’ammissione di irrilevanza che rischia di avere conseguenze ben oltre la crisi ucraina.
Pace o capitolazione? Il pericolo di una soluzione imposta
Il rischio più grande, in questo contesto, è cadere nell’illusione che la pace, in quanto tale, sia sempre un valore assoluto, indipendentemente dalle condizioni che la determinano. La narrazione secondo cui “qualunque pace è meglio della guerra” può sembrare rassicurante, ma è ingannevole.
Per comprendere l’assurdità di questa logica, si ricorra a un semplice esempio: immaginare una famiglia che si trova la propria casa occupata da delinquenti. La soluzione più ovvia sarebbe ripristinare la legalità e restituire l’abitazione ai legittimi proprietari. Oppure, in nome della “pacificazione”, si potrebbe suggerire loro di cedere una parte della casa agli occupanti, accettando un nuovo equilibrio basato sull’arbitrio della forza. Sarebbe una soluzione equa? Non credo. Eppure, è esattamente ciò che si rischia di proporre all’Ucraina: accettare un compromesso dettato dalla stanchezza, più che da un principio di giustizia.
A rendere ancora più problematico lo scenario è l’ipotesi, ventilata negli ultimi giorni, che la pace promossa dagli Stati Uniti sia subordinata a concessioni economiche, in particolare allo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. Se questa fosse la condizione per il cessate il fuoco, saremmo di fronte non a una trattativa di pace, ma a una cessione di sovranità mascherata da accordo diplomatico.
Una lezione per l’Europa: senza difesa, nessuna credibilità
L’intera vicenda evidenzia una lezione che l’Europa fatica ancora a metabolizzare: senza una politica di difesa credibile (e temibile), non esiste alcuna vera sovranità. L’idea che la sicurezza possa essere garantita esclusivamente attraverso il soft power e la diplomazia si scontra con una realtà geopolitica brutale: la pace non si negozia da una posizione di debolezza.
La storia insegna che gli equilibri internazionali si reggono sulla deterrenza e sulla capacità di risposta militare. “Si vis pacem, para bellum” non è un motto anacronistico, ma una regola eterna nelle dinamiche di potere globali. L’Europa, priva di una difesa autonoma e frammentata nelle sue scelte strategiche, si trova oggi a subire le decisioni altrui, piuttosto che a determinarle. Peraltro, in una “questione europea”.
Se c’è un aspetto positivo in questa crisi, è la speranza che l’Unione Europea prenda finalmente coscienza della propria irrilevanza strategica. Questa umiliazione diplomatica potrebbe e dovrebbe rappresentare il punto di svolta per avviare la costruzione di una vera potenza europea, capace di difendere i propri interessi e di affermarsi come attore indipendente nello scenario internazionale. Il tempo delle scelte è arrivato e l’attesa non è più un’opzione.
Ma resta una domanda fondamentale, che definisce il nostro tempo e la nostra idea di giustizia internazionale: che mondo siamo diventati, se la persona da convincere, con le buone o con le cattive, è l’aggredito e non l’aggressore?
Giorgio Carta, 5 marzo 2025
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).